PAESAGGIO, PATRIMONIO CULTURALE E TURISMO. LA IX EDIZIONE DELLA SUMMER SCHOOL "EMILIO SERENI".30/10/2017
di Rossano Pazzagli Ormai da un decennio la Summer School intitolata a Emilio Sereni e organizzata dall’Istituto Alcide Cervi costituisce un punto d’incontro fra ricerca, scuola e governo del territorio. Un luogo dove studiosi, docenti, studenti, amministratori pubblici, agenti territoriali e operatori pubblici e privati possono incontrarsi e interrogarsi sull’efficacia sociale e politica della ricerca sul paesaggio, sui modi della sua tutela e valorizzazione, sulle tecniche e sulle strategie per il suo insegnamento, sul rapporto che occorre promuovere fra cittadinanza e patrimonio culturale. Si tratta di una delle più significative esperienze formative sul paesaggio, che richiama studiosi afferenti a diverse discipline e operatori impegnati nei diversi campi della scuola e della formazione, dell’amministrazione pubblica, dei musei, dei parchi e dell’associazionismo. L'edizione di quest'anno, dal titolo “Paesaggio, patrimonio culturale e turismo”, si è posta l’obiettivo di esaminare le dinamiche del paesaggio, dei territori rurali e dei beni culturali in esso contenuti, finalizzate a percorsi di conoscenza, tutela e valorizzazione, in particolare tramite le varie forme di turismo e di integrazione con l’agricoltura. Nell’orizzonte della crisi del modello industriale, nelle inquietudini della post-modernità e della questione ambientale, tra i sentimenti di impotenza e di ineluttabilità che avvolgono il nostro tempo, questa scuola si occupa del mondo rurale e aspira a essere una spinta per il ritorno al territorio e alle vocazioni autentiche del nostro Paese. Prima di tutto nell’oggetto: il paesaggio agrario, inteso come la dimensione visibile del territorio rurale, frutto dell’incontro fecondo tra uomo e natura, ma soprattutto risultato dei processi di coltivazione e di organizzazione agricola. Uno spazio, quello rurale, a lungo vitale, poi abbandonato, dimenticato e ferito, in certi periodi perfino deriso. Uno spazio che però costituisce gran parte del territorio, al quale è necessario ridare dignità e valore, rimettendo l’agricoltura al centro dell’interesse non solo culturale, ma anche politico, economico e sociale, collegandola al patrimonio culturale e al turismo sostenibile. Il secondo aspetto è il metodo. Nello studio del paesaggio agrario, sulla scia di Emilio Sereni, si cerca qui di sperimentare effettivamente un approccio multidisciplinare, superando gli steccati delle singole discipline per recuperare una visione unitaria del territorio e dell’agricoltura come attività decisiva, non solo del passato ma anche del futuro. L’ultima edizione ha quindi posto l’accento sul rapporto tra paesaggio, turismo e beni culturali. Termini questi che sono croce e delizia del nostro Paese, l’espressione della sua bellezza e dei suoi problemi. Si promuove così un ambito di confronto delle ricerche sul paesaggio, interrogandosi sull’efficacia sociale e politica di tali ricerche, sui significati storici e sui conseguenti processi di patrimonializzazione, nella convinzione che esista in Italia, oltre alla questione ambientale in senso lato, anche una specifica questione paesaggistica. Il terzo elemento di valore da evidenziare in questa esperienza di ricerca e di formazione è il luogo. L’istituto Cervi, la casa e il Museo Cervi non sono un luogo qualsiasi. Qui non c’è solo la sede di un centro di ricerca e di documentazione, dove si conservano tra l’altro la biblioteca e l’archivio di Emilio Sereni, comprese le carte preparatorie della sua ancora insuperata Storia del paesaggio agrario italiano (1961); Casa Cervi, situata nella bassa pianura reggiano che si accosta al Po, è uno dei luoghi dove attraverso la drammatica vicenda dei sette fratelli è nata la nostra democrazia, che presenta anch’essa, oggi, preoccupanti segni di crisi, prefigurando una sorta di equazione tra paesaggio e democrazia (peraltro implicitamente suggeritaci dallo stesso Sereni). Le attività della scuola sul paesaggio si svolgono qui, ma non si tratta per questo di una iniziativa soltanto locale, né regionale. Lo hanno confermato, anche in questa edizione, la provenienza dei 70 corsisti (in massima parte studiosi, docenti e professionisti) da tutta Italia, dalla Sardegna al Piemonte, dalla Puglia al Veneto, da dodici diverse regioni italiane, il patrocinio di numerosi enti e istituzioni regionali e nazionali, tra cui due ministeri – dell’istruzione e delle politiche agricole -, la Società dei Territorialisti e le principali associazioni agricole e ambientali; così come la collaborazione scientifica di ben dodici Università e istituti di ricerca con i quali l’Istituto Cervi è convenzionato per la realizzazione scientifica della scuola. La ricerca/azione sul paesaggio è un processo ampio e intrecciato che comporta l’applicazione di conoscenze, sensibilità, attitudini ed esperienze in grado di diffondere l’idea che il territorio rurale e il paesaggio agrario dei diversi contesti regionali costituiscono, sia nelle terre della polpa che in quelle dell’osso, una risorsa importante, indispensabile e strategica per il rilancio economico e sociale dell’Italia. Se è una risorsa, è evidente che esso – il paesaggio agrario, come il suolo agricolo - va conosciuto e tutelato, difeso dai fenomeni di erosione, di consumo, di cementificazione e di alterazione della principale funzione agricola: quella della produzione di cibo e della multifunzionalità dell’agricoltura, ma inquadrandola nella cornice identitaria, strutturale e ambientale delle campagne italiane. Lo stesso approccio che vale, evidentemente, per il patrimonio culturale. Le lezioni hanno ruotato attorno a tre temi - agricoltura, beni cultuali, turismo - che rappresentano al tempo steso ambiti tematici e orizzonti politici. Come hanno testimoniato anche le edizioni precedenti, le campagne contengono tante cose:uomini, animali, agricoltura, prodotti alimentari, architetture, socialità, natura, biodiversità, valori e risorse economiche; ma anche un grande patrimonio culturale, diffuso e disperso, talora invisibile, spesso non adeguatamente conosciuto e valorizzato. Tra agricoltura e cultura, spesso le campagne sono rimaste senza voce, un’Italia pulita e appartata alla quale iniziative come questa cercano di ridare la parola, per un nuovo protagonismo, per rimettere il territorio rurale al centro dell’attenzione e delle politiche. Il piano formativo della Summer School, messo a punto dal Comitato scientifico (Rossano Pazzagli, Università del Molise; Mauro Agnoletti, Università di Firenze, Gabriella Bonini, Istituto Cervi; Emiro Endrighi, Università di Modena e Reggio Emilia; Saverio Russo, Università di Foggia; Carlo Tosco, Politecnico di Torino) si è articolato in quattro sessioni: Paesaggio, cultura e turismo; Paesaggio, turismo e sviluppo rurale; Turismo e paesaggio nei contesti regionali. Alle lezioni si sono aggiunti i workshop sul turismo nelle campagne e varie iniziative collaterali (mostre, videoproiezioni, installazioni, gite sul territorio, presentazioni di libri e film…).Tra queste, la mostra fotografica Di-SEGNI. Il patrimonio culturale nascosto nelle campagne italiane ha posto l’attenzione sul patrimonio culturale disseminato nel territorio rurale, quello fatto di piccoli manufatti, tracce artistiche e tradizioni che spesso sono rimaste nascoste ai bordi dei campi, lungo le strade rurali, nelle corti e sulle aie delle cascine, delle masserie e delle case coloniche: tabernacoli, pozzi, fontane, decorazioni, affreschi, colombaie, recinti… e tutto ciò che ha aggiunto all’arte empirica dell’agricoltura un valore estetico che ha sfidato il tempo. Si tratta di una eredità dell’Italia contadina e che oggi può offrire tanti punti per la costruzione di itinerari documentari e turistici, elementi minuti da tutelare in funzione della promozione e della valorizzazione del territorio rurale. Di particolare rilievo, inoltre, la gita di martedì in bicicletta e in battello lungo il Po: Tra argini e pioppi, itinerari nella Bassa Reggiana, che ha costituito una piccola ma significativa esperienza di turismo lento: la bicicletta, la nave sul Po e i tragitti a piedi sono stati non solo mezzi per spostarsi, ma anche modi per cambiare il punto di vista. La percezione di un fiume visto da dentro il fiume, ad esempio, è un punto di vista assolutamente insolito, inusuale. Ecco, dovremmo provare tanti e diversi punti di vista per avvicinarci al patrimonio, tutto il patrimonio e non solo quello codificato. Perché il patrimonio, codificato o no, è qualcosa a cui si attribuisce un valore che abbiamo visto emergere chiaramente anche nelle aree rurali della bassa pianura. Il patrimonio è l’insieme dei valori che gli abitanti di una comunità, ma anche chi la osserva dall’esterno, attribuiscono alle cose. La stessa esperienza, ovviamente con mezzi diversi dalla bicicletta e dalla nave, si potrebbe fare per la montagna, per le colline, per le aree costiere e palustri del nord, del centro o del sud, per quell’Italia dimenticata o trascurata a cui sarebbe opportuno ridare voce, che attende di essere considerata prima di morire davvero per sottrazione di energie e risorse. Tra i molti temi e nodi problematici affrontati, emerso il tema delle aree interne, dei paesi e dei borghi rurali, ponendo il problema delle comunità locali che, come il paesaggio, hanno subito processi di semplificazione, di abbandono, di depotenziamento. Dal canto nostro invece è emersa, anche nei workshop, la necessità di un rafforzamento delle comunità locali e della partecipazione. Questo è un punto critico, perché di questo ci sarebbe bisogno, mentre invece stiamo andando in direzione opposta, cioè mentre noi parliamo di rinascite territoriali, di empowerment delle comunità locali, di riorganizzazione dei territori… in gran parte delle aree rurali italiane continuano a far sentire i loro effetti lo spopolamento, l’abbandono, la desertificazione produttiva e la sottrazione di servizi ai territori. La domanda di sfondo che ha accompagnato la SummerSchool fin dalla relazione introduttiva è stata duplice: quale agricoltura e quale turismo? La domanda su quale agricoltura ha implicato la messa in discussione dei fondamenti economici su cui si regge al giorno d’oggi l’agricoltura industriale e la gestione della campagna produttiva; ha richiesto di interrogarsi sulla natura della domanda, la qualità dell’offerta, la struttura dello scambio; ha comportato la conoscenza il ri-conoscimento e la gestione diffusa dei beni comuni (terre, acque, paesaggio, sovranità alimentare, saperi agronomici). In tal senso una neoagricoltura consapevolmente multifunzionale, in grado di consentire un’offerta diffusa di beni alimentari e servizi eco-sistemici per un territorio vasto e integrato (il distretto, la bioregione, il parco o altre tipologie di sistema locale) può rappresentare tra le altre cose l’avanguardia di nuove economie e il contesto più propizio per la valorizzazione del patrimonio culturale rurale. E quale turismo? In un contesto come quello italiano, fortemente territorializzato, il turismo ambientale e culturale, quello enogastronomico, il turismo cosiddetto sostenibile, consapevole o esperienziale diviene, oltre che obiettivo economico, anche occasione per rafforzare il capitale umano e sociale, il sistema delle relazioni a livello regionale e interregionale, l’identità stessa dei luoghi. Per questo la sua crescita deve essere alimentata da un adeguato sistema di governo e di organizzazione del territorio, affinché quest’ultimo sia prima di tutto conosciuto, fruito e apprezzato dai suoi abitanti, rivitalizzando anche le connessioni tra vecchie e nuove generazioni, per le quali la scuola e l’università rappresentano lo strumento privilegiato. Dal lato delle istituzioni e del mondo imprenditoriale occorre promuovere una più marcata integrazione dell’offerta turistica complessiva, di cui l’enogastronomia costituisce un segmento significativo, ma che non può essere intesa come separata dai centri storici, dalle aree protette, dalle testimonianze archeologiche e culturali in senso lato, dalle feste e dalle tradizioni popolari. Il turismo è un’opportunità e un rischio, per certi aspetti. Esso tende infatti a produrre modelli di consumo omologanti e standardizzati, a volte con tendenze alla colonizzazione rurale e culturale con conseguente perdita d’identità, di valori, di indebolimento del patrimonio culturale custodito nelle campagne e connessi processi di espulsione degli abitanti (agricoltori) dai luoghi tradizionali. Per questo, fare turismo nelle aree rurali non deve significare allontanare i protagonisti di quelle aree, coloro che le hanno vissute e organizzate nel tempo. Del resto, non deve succedere quello che è successo nei centri storici delle città d’arte, dove il turismo ha cacciato via negozi, abitanti, i bambini che giocano in strada e gli anziani che stanno sulle panchine, magari semplicemente perché diventa troppo costoso abitare e vivere lì. Comunità locali, comprensione, partecipazione, consapevolezza sono dunque emersi come concetti necessari e come tematiche da affrontare e sperimentare. In questa ottica, il paesaggio ci serve allora per rimettere insieme le cose, per ricomporre le separazioni del nostro tempo. Il paesaggio non è un dato, ma un processo, diceva Sereni. Il rapporto tra campagne e turismo è un vasto campo di ricerca su cui elaborare molte delle strategie di rigenerazione dei valori e dell'economia, per riannodare fili di una rete spezzata di coesione territoriale: quella tra città e campagna, tra borghi e contrade, montagna e pianura, agricoltura e alimentazione, ed anche, in fondo, tra cultura e politica. Questa edizione della scuola è stata molto sereniana, nel senso che ha insistito molto sui processi e sulla natura dinamica e viva del paesaggio. Nella prima giornata Giuliano Volpe e Daniele Manacorda hanno parlato del paesaggio come “organismo vivente”. Organismo vivente e prodotto storico, frutto della cooperazione e dell’incontro tra uomo e natura. Paesaggio come prodotto che si trasforma, ma anche come fattore propulsivo per il turismo. Quindi una prima conclusione è questa: il territorio, il territorio rurale in particolare è la prima risorsa dell’Italia e deve tornare al centro del processo di sviluppo. Ai fini dell’integrazione agricoltura-cultura-turismo c’è dunque molto da fare; è un campo molto aperto e interessante in cui progettare, fare, realizzare e applicare la filiera che lega conoscenza, tutela e valorizzazione. Il paesaggio agrario, in particolare, è la dimensione visibile di come si coltiva e di come si governa il territorio, di come si relazionano città e campagna, produzione e mercato, lavoro e tempo libero. La profonda tradizione economica e civile delle campagne italiane, l’innovazione, unita al rispetto dei cicli naturali, la bellissima metafora di Alcide Cervi “dopo un raccolto ne viene un altro” sono emersi come i riferimenti ideali, lo spirito di questa scuola, ma soprattutto come spinta a conoscere, difendere e valorizzare il paesaggio italiano, che rappresenta non solo il volto della nostra agricoltura, ma anche un bene comune e una componente essenziale del patrimonio culturale italiano, una leva che ci può aiutare a rispondere alla crisi del nostro tempo.
Comments are closed.
|
Archivio
Gennaio 2023
Categorie
Tutti
Scarica qui i numeri completi della Rivista
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tutti i diritti sono riservati © Kinetès-Arte. Cultura. Ricerca. Impresa. 2016 |
|

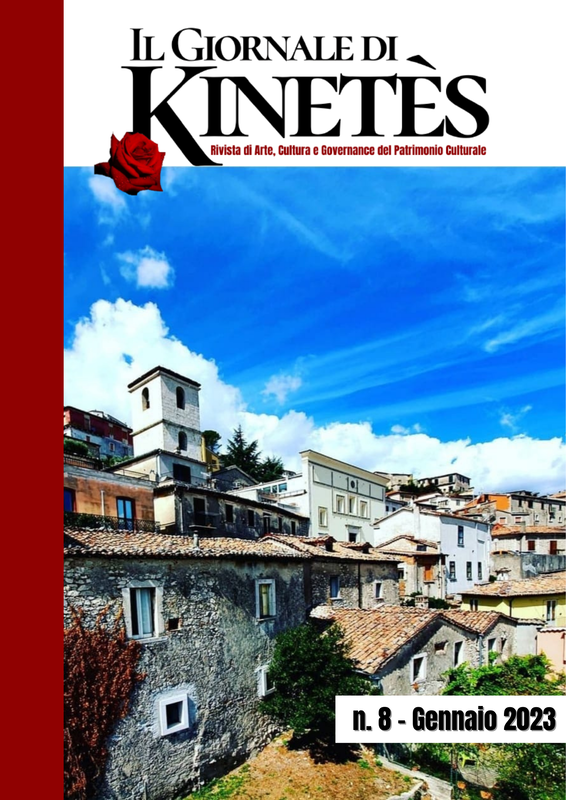
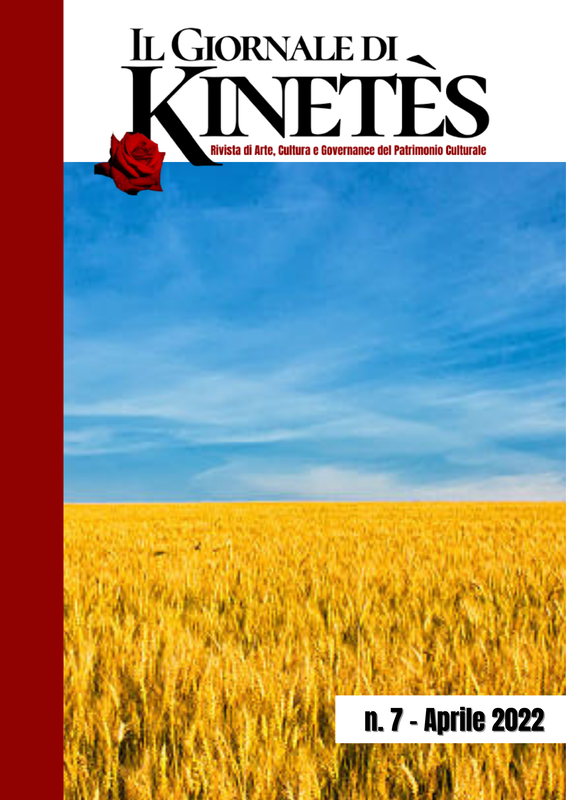
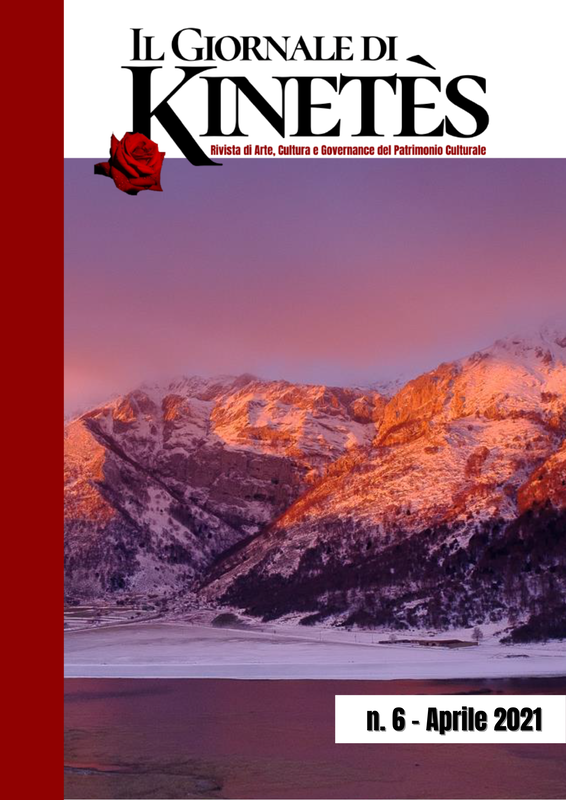
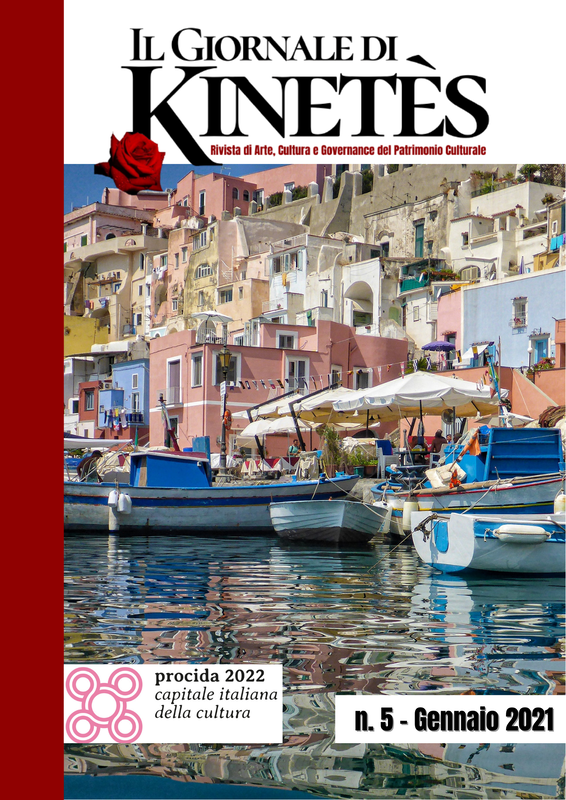
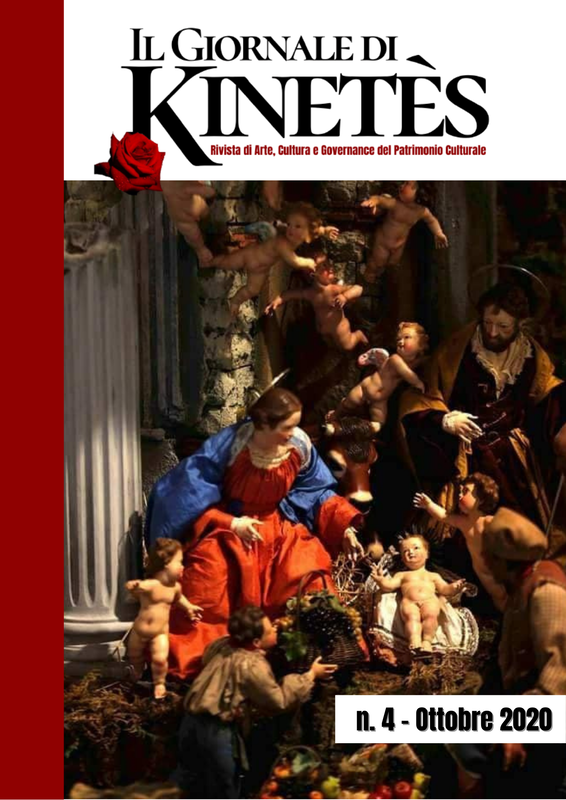





 Feed RSS
Feed RSS

