di Alessia Frisetti Le zone montane della nostra penisola, in particolar modo le aree appenniniche, non includendo grandi centri urbani, custodiscono ancora molti paesaggi storici tuttora ben riconoscibili. Tali comparti geografici sono, quindi, paradigmatici per lo studio delle dinamiche insediative che si sono sovrapposte dall’antichità ad oggi. Questi paesaggi sono ricchi di piccoli e medi borghi d’altura, spesso nati dallo sviluppo di originari castelli medioevali, ma anche di abitazioni rurali sparse, collegate alle attività produttive tipiche della montagna quali allevamento, estrazione e lavorazione delle materie prime. Architettura rurale, produzioni e aspetti tradizionali del vivere in altura sono al centro di questo convegno che, attraverso una lettura multidisciplinare, vuole accendere nuovamente i riflettori sulle nostre montagne, puntando l’attenzione sulla valorizzazione della memoria storica che favorisca il recupero dei caratteri peculiari di questi contesti al fine di contrastarne l’abbandono.  Il convegno è organizzato dal LATEM (Laboratorio di Archeologia Tardoantica Medioevale), già promotore di una serie di eventi on line, come l’Accademia Popolare di Archeologia che - con oltre 20 conferenze sui maggiori temi dell’archeologia contemporanea - ha suscitato l’interesse di centinaia di ascoltatori, tra addetti ai lavori, appassionati e semplici curiosi, nell’ottica di un avvicinamento di questa disciplina al grande pubblico. Le giornate del 19-20 e 21 aprile, dedicate all’evento organizzato su piattaforma google meet, si propongono di offrire un approfondimento su alcune regioni montane della penisola che, pur mostrando le proprie peculiarità, possono svelare molti caratteri comuni. “Queste nostre montagne…da Nord a Sud”, è il titolo della prima giornata che ospita diversi studiosi, di altrettanti Atenei italiani e Soprintendenze regionali, che da anni dedicano i propri sforzi alla conoscenza delle zone appenniniche. L’organizzazione del manso nella Carnia tardo medioevale, gli effetti della produzione di carbone sul paesaggio boschivo e la gestione delle aree pubbliche, la vita sugli Appennini settentrionali vista attraverso le fonti, l’evoluzione degli insediamenti d’altura nell’areale emiliano, il lungo processo sociale, economico ed ingegneristico che porta alla nascita di un castello, sono i temi affrontati nella mattina del 19 aprile, presieduta dalla Professoressa Rossella del Prete (docente di Storia Economica presso l’Università del Sannio) ed introdotta dai saluti istituzionali della professoressa Paola Villani, Direttrice del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli e del Dottor Franco Imperadore sindaco di San Potito Sannitico (CE). In continuità con l’ultimo intervento mattutino, la sessione pomeridiana apre con un approfondimento sulla zona marchigiana. Al centro del dibattito ritroviamo, infatti, la comunità che nel medioevo abitava a Monteboaggine (Montecopiolo, PU) e conosciamo le pratiche costruttive ed abitative nella valle del Fiastrone, punto di partenza per riflessioni di più ampio respiro sulle Marche centro-meridionali. In un fisiologico viaggio da Nord a Sud si giunge, quindi, in Lazio dove le tipologie abitative pastorali della valle del Liri offrono numerosi spunti di riflessione, per terminare con un’approfondita analisi degli insediamenti sui monti della Laga. Quest’ultimo importante intervento apre la discussione conclusiva che vuole fare il punto sugli studi “Appenninici” ed introdurre gli argomenti del giorno successivo.  “Convergenze sul Matese”, infatti, è il titolo del secondo appuntamento (20 Aprile) che non solo vuole proporre una sintesi su un’area Appenninica, a cavallo di Molise e Campania, poco conosciuta dal punto di vista storico, architettonico e sociologico, ma anche puntare l’attenzione su un contesto geografico che, come altri simili in Italia, sta soffrendo del continuo ed inesorabile abbandono da parte dei suoi abitanti più giovani, difficilmente motivati a restare in un territorio ‘scomodo’ che offre poche certezze. In un alternarsi di contributi che spaziano dall’archeologia, all’architettura all’economia sociale, si inizia con un intervento sul sito preromano di Capo di Campo individuato nella zona centrale del Matese, per poi passare ad alcune interessanti pratiche costruttive tradizionali, conosciute sul versante molisano del massiccio montuoso. I processi di produzione in rapporto ai paesaggi rurali occupano la parte centrale della mattinata, presieduta da Mario Pagano Soprintendente per le Province di Caserta e Benevento. Queste tematiche introducono ad una problematica altrettanto attuale e centrale nel palinsesto del convegno: il mondo rurale contemporaneo sta scomparendo, come recuperarne la memoria? La prima parte della giornata, con un salto indietro nel tempo, si conclude con un intervento sulla gestione delle risorse idriche nella Campania interna appenninica in epoca medioevale e post medioevale. La sessione pomeridiana, presieduta dal Professore Federico Marazzi (ordinario di Archeologia Medievale presso l’UniSOB) prosegue l’excursus sull’area matesina, affrontando temi riguardanti i cicli produttivi dell’olio e della ceramica dal medioevo fino ad epoca moderna, lo sfruttamento delle risorse naturali come le miniere di bauxite presenti sulle alture orientali e gli edifici abitativi rurali con le annesse strutture produttive. Un ulteriore momento di discussione finale occupa il pomeriggio del 21 aprile quando - in occasione della presentazione del volume “La valle del Volturno nel medioevo. Paesaggio, insediamenti e cantieri” edito dalla Volturnia Edizioni per la collana ‘Studi Vulturnensi’ – si prevede l’intervento di alcuni docenti di archeologia medioevale e architettura, in un dibattito coordinato da Daniele Ferraiuolo de l’Institute de Recherche e d’Histoire de Textes, Paris. Promosso dal LATEM, l’evento vede un parterre di Enti, Istituzioni ed Associazioni che, tramite patrocini e collaborazioni, si sono attivati per la promozione e divulgazione di queste giornate di studio. Il Comune di San Potito Sannitico (CE) nell’alto casertano, che da due anni ospita la sede del LATEM, ha prontamente concesso il patrocinio confermando quella sinergia di intenti dichiarata nella convenzione stipulata con l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, di cui il LATEM è parte integrante. Dal momento che i temi trattati nei diversi interventi afferiscono per buona parte al settore medievistico e gli stessi organizzatori operano in questo periodo storico, è stato gioco forza intercettare anche il patrocinio della SAMI (Società degli Archeologi Medievisti Italiani) da diversi decenni promotrice di eventi scientifici e divulgativi di ampio respiro. A queste Istituzioni si aggiungono quelle che operano direttamente nei territori interni della Campania. Comunità Montana del Matese, Parco Regionale del Matese e Gal Alto Casertano hanno offerto con entusiasmo il proprio patrocinio al convegno. Un evento del genere, volto al territorio, non può però prescindere dalla collaborazione con enti ed associazioni locali. Rena Rossa in primis, che ha organizzato insieme a Briganti del Matese diverse ricognizioni ad alta quota, per acquisire dati sulle pratiche costruttive e di produzione che possano essere anche oggetto di percorsi turistici tematici; ma anche Cuore Sannita e Matese Adventures che insieme alle altre associazioni del settore turistico-culturale sono parte attiva de la Consulta del Matese già invitata a collaborare, ed infine Ru.De.Ri un’associazione culturale che si dedica allo studio e alla promozione del Rural Design. La collaborazione attiva vede anche la partecipazione della Volturnia Edizioni con cui il gruppo di ricerca LATEM ha curato e portato a termine diversi progetti editoriali, l’Associazione Culturale Kinetés che si propone quale interlocutore per la pubblicazione degli Atti del Convegno e Zona Rossa web-tv la cui pagina facebook ospita la diretta della tre giorni in programma. Nella consapevolezza che gli Appennini conservano ancora un forte legame con la tradizione ed il passato, ci si aspetta che questo convegno possa accendere la miccia di un frizzante e stimolante dibattito futuro. Un evento culturale con queste caratteristiche potrebbe trasformarsi in un appuntamento annuale, aperto a tutte le aree di montagna e senza limiti cronologici, con un approccio multidisciplinare che non tralasci alcun aspetto del ‘vivere la montagna’ e con l’ambizioso obiettivo di ricordare a tutti che ci sono ottimi motivi per ‘non lasciare la montagna’. In un momento storico particolare come quello che stiamo vivendo, infatti, la vita tranquilla e per molti aspetti, più sana e genuina che caratterizza queste zone, si sta proponendo sempre più come una valida alternativa all’abitare compulsivo delle grandi città.
Comments are closed.
|
Archivio
Gennaio 2023
Categorie
Tutti
Scarica qui i numeri completi della Rivista
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tutti i diritti sono riservati © Kinetès-Arte. Cultura. Ricerca. Impresa. 2016 |
|

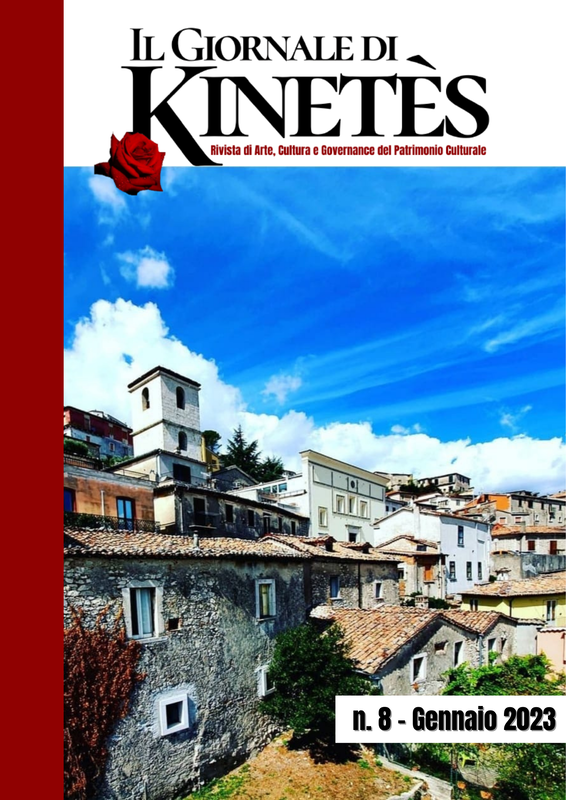
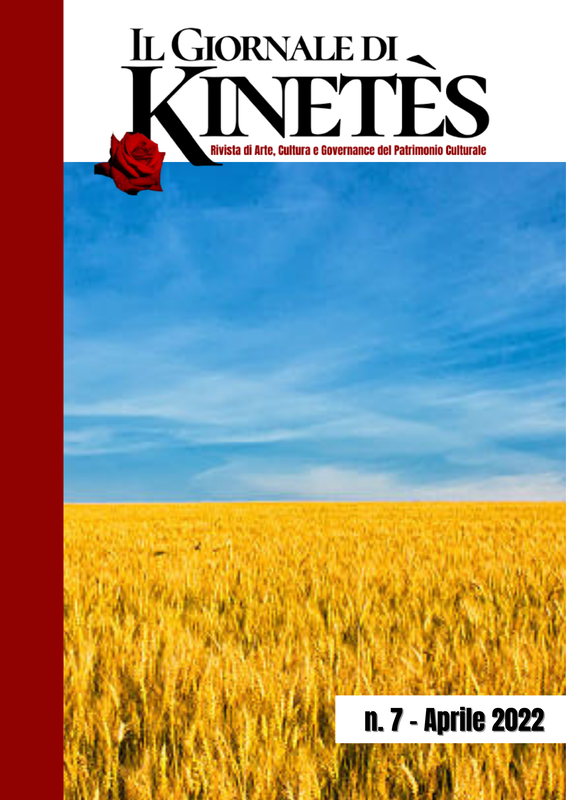
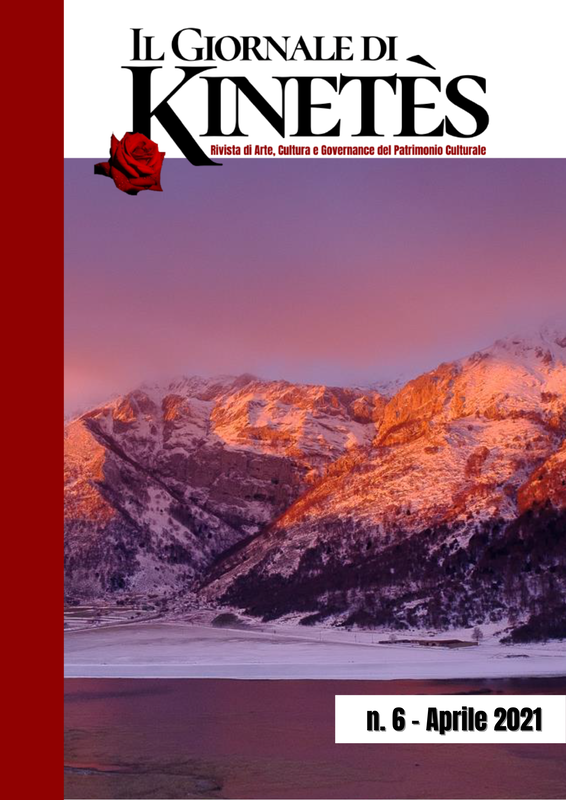
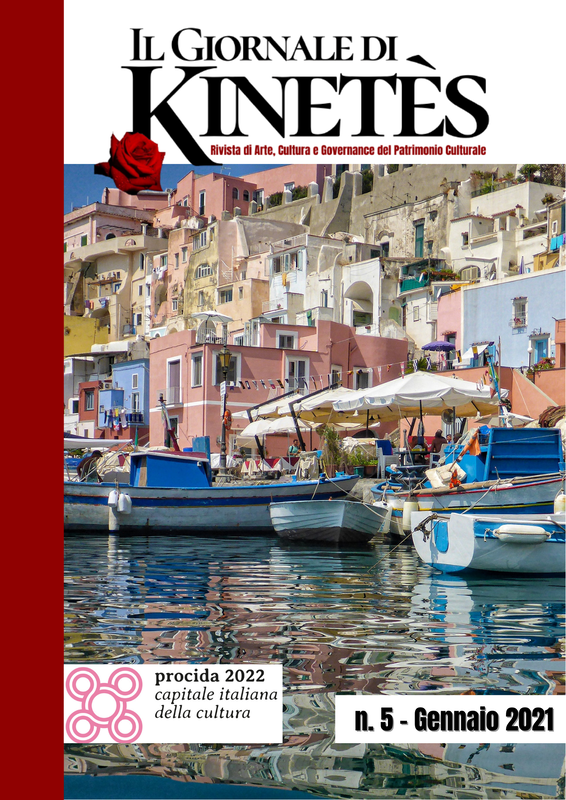
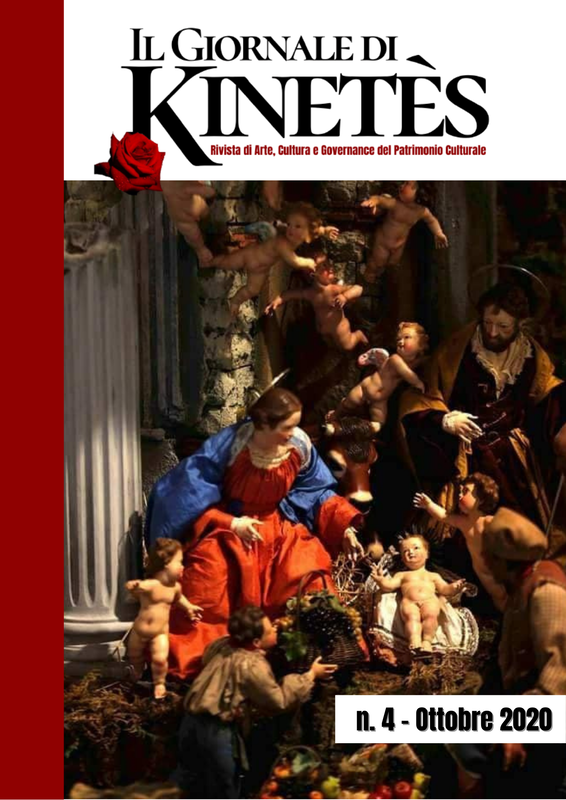


 Feed RSS
Feed RSS

