|
di Rossella Del Prete “si perdoni a un povero studioso di storia questo grido di artista!” «La ricerca storica è per me uno spazio di gioia e di passione intellettuale. Provo sempre un brivido prima di entrare in un archivio o in una biblioteca: cosa troverò? […] Che fortuna aver potuto leggere tante storie interessanti, alcune divertenti, altre da far gelare il sangue, alcune sorprendenti, altre familiari…» [N. Zemon Davis, La passione della storia, 2007, p. 174]. Un approccio alla ricerca storica, quello di Natalie Zemon Davis, apparentemente libero e passionale, ma con un limite indelebile: quello imposto dalle fonti e dalla dimensione scientifica della Storia che altrimenti rischierebbe di essere sopraffatta dall’emozione, dalla simpatia o dall’empatia, piuttosto che veicolare l’estraneità ed insieme la familiarità del passato. Appare, dunque, impossibile abbandonare il concetto di Storia come scienza, nella convinzione che si faccia Storia attraverso un’interiorizzazione, un’autoillusione più o meno consapevole dello storico. Il “laboratorio borghese” ottocentesco espulse dalla scienza storica ogni aspetto creativo, rinnegando le sue radici artistico-letterarie in favore di una disciplina che tendeva sempre più a conformarsi alle scienze sperimentali, allora in ascesa sociale. Le tragedie del Novecento mandarono poi in frantumi la visione “giustificazionista” della storia, mettendo in crisi lo storicismo, ma anche la Storia come disciplina. Si aprì la strada ad una nuova creatività, intesa come possibilità di elaborare la memoria del passato, come costruzione sociale consapevole. Fondamentale è stata l’apertura alle altre discipline, che studiano l’uomo e il suo ambiente, e l’esplorazione di mondi sino allora trascurati (non più soltanto i grandi fatti politici, ma le vicende dell’uomo comune, le mentalità, la vita materiale, la componente femminile - fino ad allora praticamente invisibile -, l’ambiente, il clima) e, soprattutto, al valore della narrazione [P. Prodi, Creatività, storia, politica: alcuni spunti sul tema, 2004]. Per decenni, la storia del Novecento è stata raccontata dalla letteratura, in cui la complessità del reale, ostinatamente negatasi alla conoscenza degli storici, riconduce ad una molteplicità di percorsi esistenziali difficili da individuare nelle grandi sintesi politiche e ideologiche. La letteratura, con la sua capacità di comunicare e trasmettere conoscenza, coglie e risolve, più intuitivamente, quello che altre elaborazioni di pensiero sono più lente a metabolizzare e a formulare compiutamente, creando quel vecchio complesso di inferiorità degli storici (scrittori mancati) che, al talento, alla creatività di una fantasia, capace di intrecciare trame e risvolti psicologici tra scenari e personaggi, «hanno sostituito l’uso dei documenti e delle fonti chiedendo in prestito agli archivi vicende da raccontare e protagonisti da descrivere»[G. De Luna, La passione e la ragione: il mestiere dello storico contemporaneo, 2004]. Per sottrarsi all’ossessione di raccontare una storia lineare non del tutto conoscibile, e dunque poco oggettiva, lo storico deve accettare la sfida del romanzo, cogliendovi nuove opportunità metodologiche, senza rinnegare la struttura della sua disciplina, ma cercando di spezzare i compartimenti stagni ereditati dal positivismo, nella consapevolezza che il lavoro sulle fonti non appartenga solo alla fase erudita della sua ricerca, ma è parte integrante della narrazione. Più è forte la relazione emotiva che si instaura con le fonti, più è alta l’intensità del registro narrativo, la capacità di colpire, emozionare, interessare, coinvolgere il lettore [Ibidem]. «Cosa nasconde l’eccesso di difesa che ha strutturato l’organizzazione formativa dei saperi? Da un’impermeabile accademia della conoscenza s’è posto comunque un problema di non poco conto: la memoria del mondo, la storia dei percorsi cognitivi e la stratificazione dei rovelli conoscitivi possono essere negati per una mitizzazione del nuovo?» [G. Cantone, L’erranza interrogativa della modernità, 2010][1]. La strenua difesa di una possibile creatività della storia e dell’intensità del suo registro narrativo, passa attraverso il valore della sensibilità e forse, prima ancora, della interdisciplinarità. «Storia e sensibilità: ecco un argomento nuovo. Non conosco un libro che ne parli. Non vedo neppure qualche pubblicazione dove si trovino formulati i molteplici problemi che esso implica. Ed ecco dunque – si perdoni a un povero studioso di storia questo grido da artista – ed ecco dunque un bell’argomento! Tanta gente se ne va sconsolata di tanto in tanto: non c’è più niente da scoprire, a quel che pare, su questi mari troppo battuti. Si immergano nelle tenebre della psicologia alle prese con la storia, e riprenderanno gusto all’esplorazione» [L. Fevbre, La sensibilità e la storia, in Id. Problemi di metodo storico, 1976, pp. 121-138]. E il gusto all’esplorazione, se ripreso senza pregiudizi “disciplinari”, pone lo storico di fronte alla categoria della bellezza che oggi diventa economia della bellezza, una dimensione concreta e misurabile della nostra economia alla quale gli storici potrebbero e dovrebbero contribuire con una partecipazione ed una condivisione di oneri ed onori decisamente più “visibile”. E invece, il ruolo degli storici, così come quello degli artisti, è ancora sorprendentemente poco protagonista nell’economia dell’arte e della cultura. Ricerche recenti confermano una prepotente invasione di campo nell’arte e nella cultura di economisti, aziendalisti, giuristi, che sempre più spesso tendono a sottovalutare, quasi ad estromettere, l’importanza della ricerca storica, nelle sue varie declinazioni (storia sociale, economica, delle istituzioni, dell’arte, della musica, della cultura, dell’ambiente…). Dal canto loro, gli storici, gli archeologi, gli archivisti, gli artisti (e tutta quella parte di cosiddetti umanisti, dai quali economisti e giuristi apparirebbero oggi assai distanti, pur appartenendo tutti, di fatto, alla categoria delle scienze sociali), poco hanno fatto finora per esercitare un ruolo fondamentale nella valorizzazione di quell’immenso patrimonio di bellezza che loro, per primi, han sempre studiato o prodotto, privilegiando ciascuno la propria turris eburnea, in un idilliaco otium letterario che, per secoli, si è tenuto troppo distante dal negotium. Eppure, collezioni, archivi storici, memorie di comunità, paesaggi, costituiscono il serbatoio documentale di partenza per un’innovativa progettazione culturale, che oggi fa i conti con la categoria economica della bellezza, del turismo culturale e con l’industria creativa e culturale. Qualche mese fa uno studio della Fondazione Italia Patria della Bellezza, in collaborazione con Prometeia, ha ufficialmente introdotto la categoria dell’Economia della Bellezza quale nuovo termine socio-economico. Fino a quando ne avevano parlato singoli ricercatori, storici o umanisti, la bellezza non aveva acquisito valore economico…Oggi è ufficiale, sebbene sia ancora al di là da venire una vera presa di coscienza collettiva circa la rilevanza che questa leva riveste nello sviluppo del Paese e nell’elaborazione di strategie di crescita. Fissando tre obiettivi principali - quantificare il contributo della bellezza (in tutti i suoi aspetti) alla ricchezza del paese; stimare il potenziale di crescita; stimolare il dibattito su come valorizzare e promuovere la bellezza diffusa nel paese -, la ricerca ha identificato i settori che costituiscono l’Economia della Bellezza e ne misurano il valore attuale - beni di consumo di qualità; beni tecnologici di ingegno; industrie creative; industria turistica; investimenti pubblici; altruismo e mecenatismo - e, comparando le migliori pratiche dei paesi europei, ha individuato le politiche necessarie per esprimere al meglio questo potenziale [http://www.patriadellabellezza.it/progetti/show/Economia-della-Bellezza-2/]. La conclusione è sintetica, numerica, indicativa di un valore oggi determinante, economico, dunque, persino più avvincente della stessa Bellezza: quella italiana vale 240 miliardi di euro e costituisce il 16,5% del PIL italiano, ma con le giuste azioni il suo valore potrebbe crescere di ulteriori 130 miliardi. È abbastanza convincente, dunque, il valore della Bellezza? Forse, dopo questo studio, oggi lo è di più. Non conosciamo la composizione del gruppo di ricerca, ma non sorprenderebbe scoprire che non abbia incluso degli storici. Tuttavia, lo scambio di saperi, di approcci metodologici alla ricerca, alle possibili applicazioni dei suoi risultati, nel mondo del lavoro e della produzione della bellezza, costituiscono oggi un imprescindibile bagaglio di esperienze. La governance dei beni, delle attività creative e culturali, avverte l’esigenza di sperimentare prassi di gestione tipiche del mondo imprenditoriale e possibili modelli di gestione e di promozione del territorio, e delle sue bellezze a più livelli, anche di natura “politica”. Il rapporto tra patrimonio culturale e sviluppo economico territoriale è un tema centrale, complesso e strategico: culture, identità, conoscenze, innovazioni e creatività sono fattori rilevanti dei processi di progresso socio-economico, e ogni investimento in cultura/bellezza genera un mutuo scambio di valore. Nel corso dei secoli la domanda d’arte nel nostro Paese ha lasciato un capitale tangibile (palazzi, collezioni di opere d’arte, manufatti, composizioni musicali e teatrali) sempre più significativo per la nostra economia. Ma chi, oggi, decide cosa sia patrimonio culturale da tutelare e valorizzare? Chi, per primo, decreta il valore di un bene storico, artistico o paesaggistico? Chi declina il valore della memoria? Chi produce conoscenza su eventuali itinerari culturali da mettere a valore? Chi fornisce, dunque, “materia prima” agli operatori dei vari settori economici individuati dalla ricerca sull’Economia della Bellezza? Rispondiamo senza alcuna esitazione: gli storici. Che la Storia - con la maiuscola - possa avere un ruolo nell’industria creativa o nel turismo culturale è ormai assodato da decenni. Basti pensare a quante idee siano giunte in prestito all’alta moda o al design, in materia di abbigliamento, tessuti, broccati o di elementi di arredo. È opportuno ricordare, per il caso italiano, la grande diffusione dei musei etnografici che, a partire dagli anni Settanta, ebbero come riferimento il patrimonio intangibile della conoscenza storica, o i più recenti musei d’impresa, in cui - quando non si privilegino allestimenti di nuovo design -, il racconto dell’impresa e dei suoi protagonisti è affidato ai documenti (tecnici, amministrativi, commerciali), ai materiali iconografici, ai prodotti e ai macchinari conservati e valorizzati all’interno degli archivi o delle sale espositive. Segni materiali che possono considerarsi a tutti gli effetti beni culturali, espressione delle valenze etiche ed estetiche dell’impresa e della capacità di innovazione che dal passato si trasmette al presente e che, in più di un’occasione, offre spunti per nuove serie di prodotti. Le imprese, infatti, non si limitano ad esibire il loro patrimonio museale, ma lo fanno rivivere, attingendovi per ispirare, riproporre e così realizzare nuovi prodotti e/o il loro packaging. Le trasformazioni che hanno caratterizzato il settore turistico negli ultimi decenni e che per semplicità qui sintetizziamo nei concetti di turismo post-moderno e turismo dell’esperienza, hanno creato un contesto particolarmente favorevole proprio all’uso della storia nella progettazione delle esperienze turistiche. Il turismo è divenuto così uno dei canali di divulgazione per la conoscenza storica e questo, ovviamente, ha aperto una lunga serie di problematiche, che in letteratura erano in parte state già affrontate nel ragionamento sul rapporto fra cultural heritage e turismo. Tuttavia, l’aspetto davvero interessante è che la ricerca storica sia ormai diventata una delle componenti del processo innovativo degli stessi prodotti turistici. La necessità di molti tour operator di rinnovare continuamente la propria offerta turistica ha stimolato la progettazione di nuove destinazioni e l’introduzione di nuove esperienze turistiche per i propri clienti. La storia ha potuto così proporsi come una delle fonti culturali attraverso le quali progettare nuovi itinerari, nuove esperienze e nuovi prodotti. Non è difficile immaginare un processo innovativo turistico che inizi con l’attività di ricerca storica, prosegua con la sua applicazione allo sviluppo dei prodotti, per giungere, infine, ad una loro produzione su vasta scala. Il ruolo cruciale che gli storici potrebbero condurre per ciascuna di queste fasi, sarebbe altrettanto, facilmente, immaginabile. Puntare su una ricerca storica applicata per costruire l’offerta di servizi culturali per il turismo, è oggi un caso d’interesse e, in sempre più numerose occasioni, una realtà molto produttiva. Se, invece di contare i biglietti staccati alle mostre o ai musei e le permanenze più o meno brevi nelle strutture ricettive, analizzassimo la quantità e soprattutto la qualità delle risorse umane addette al settore dei beni culturali, ci accorgeremmo di quante competenze e di quanti talenti sprechiamo ogni giorno, soprattutto tra i giovani. Lavorare per migliorare la conoscenza del territorio e le opportunità di circolazione di idee e informazioni dentro e fuori le istituzioni culturali (Università, Scuole, Archivi, Musei, Teatri…) dovrebbe essere uno dei primi obiettivi. La produzione di contenuti, reperiti con rigorosa metodologia della ricerca, verrà poi tradotta in offerta turistico-culturale o in strumenti di gestione dei beni culturali. La costruzione di itinerari culturali alternativi, originali e tematici, indurrà a guardare e a ‘visitare’ luoghi, palazzi, paesaggi - mai considerati fino ad ora siti d’interesse turistico - con occhi diversi; racconterà il loro background, rievocando storie di vita, di lavoro e produzione, usi, costumi, enogastronomia, valorizzando la strettissima relazione esistente tra la ricerca storica, protetta all’interno dei suoi spazi ufficiali, e la città. La visita ad un museo o ad un sito Unesco, già ‘impacchettati’ in un ripetitivo itinerario turistico, non può esaurire il piacere di condividere i risultati dell’indagine storica, che potrà continuare per le strade, nelle piazze, nelle fabbriche dismesse, nei giardini, lungo i sentieri della transumanza o dei boscaioli, lungo i fiumi. Una città o un paesaggio potranno essere percorsi, anche più volte, guidati dalle immagini di una collezione d’arte, alla scoperta di luoghi ritratti da artisti che - soltanto dopo averli visti -, li consegnarono alla storia, o dalla rievocazione letteraria di storie di vita vissuta, individuale o collettiva. Ma per facilitare, arricchire e rinnovare questo curioso e interminabile viaggio nel tempo è necessario che la storia esca allo scoperto e coniughi al meglio turismo e cultura. La valorizzazione del patrimonio culturale a fini economici, come quelli del settore turistico, passa inevitabilmente attraverso la conoscenza delle risorse materiali e immateriali presenti sul territorio. Senza la ricerca storica lo storytelling, oggi tanto abusato dagli operatori di marketing, rischia di diventare un inganno, una beffa. La Cultura va esplicata in un’ottica integrata di sistema, incrementando programmi di ricerca interdisciplinari ed interventi il più possibile condivisi e, soprattutto, affidandosi a professionalità adeguate per gestire ciò che costituisce un indiscutibile made in Italy, molto apprezzato all’estero, ancora poco riconosciuto in Italia. La tutela e la valorizzazione della Bellezza italiana rimane tuttavia un problema di difficile gestione. Oltre a conoscerla ed a “riconoscerla”, è necessario mettere in luce i profili di complessità delle organizzazioni culturali, ciascuna con differenti esigenze organizzative e gestionali a seconda del campo specifico di attività (museale, archivistico, dello spettacolo dal vivo, archeologico). Ma, è noto, un mercato culturale non porta necessariamente sviluppo economico: non possono crearsi vere economie se, nel sistema locale, non esiste innanzitutto una capacità diffusa di attribuire senso e valore alle esperienze culturali e dunque alla bellezza. Il vero problema è, dunque, creare un contesto di esperienze accessibili, che consentano di dare valore e significato al bene culturale nella sua accezione più ampia, superando una concezione della valorizzazione culturale legata pressoché esclusivamente al tempo libero ed al turismo: la gestione affaristica e commerciale del bene culturale continua a sfruttare risorse umane e materiali senza pensare al loro futuro e a come rigenerarle. Il “consumo culturale”, allora, non può essere solo turistico e deve investire in formazione e ancor più in “educazione al patrimonio”: gli Italiani dovrebbero imparare - sin da piccoli e con strategie didattiche mirate -, ad entrare più spesso nei musei, nelle biblioteche, nei giardini e nei palazzi storici, con una maggiore responsabilità di fruizione. Al contrario, persistono oggi alcuni paradossi tutti italiani: sale da concerto poco frequentate, musei che restano legati ad un’obsoleta azione conservativa che poco o nulla interagiscono con il presente, beni archeologici abbandonati all’incuria di una gestione pubblica, troppo spesso incapace di assolvere ai suoi compiti. Abbiamo città dell’arte e della cultura, ma non abbiamo i “cittadini dell’arte e della cultura”. Sono ancora troppo bassi i livelli di partecipazione culturale degli Italiani nel contesto europeo. È oggi assolutamente necessario «formare un pubblico consapevole, colto e moderno. E farlo là dove il pubblico è ancora tutto senza discriminazioni di ceto e di biografia personale: a scuola innanzitutto» [A. Baricco, La Repubblica.it, 24 febbraio 2009]. Il patrimonio culturale italiano è in larghissima parte affidato all’istituzione statale, all’ente locale e regionale che non sempre accetta l’interferenza del privato e viene spesso frenato da vincoli legislativi e lentezze burocratiche, da carenze di capacità gestionali e soprattutto dalla scarsità di professionalità adeguate ai tempi che viviamo ed al settore strategico da riqualificare, quello culturale, appunto. È, in sintesi, questione di metodologia dell’approccio culturale che oggi, più che mai, ha bisogno della ricerca storica, della sua capacità di produrre e rigenerare conoscenza e narrazione. «Organizzare il passato in funzione del presente: tale si potrebbe definire la funzione sociale della storia». Lucien Fevbre [Problemi di metodo storico, Torino Einaudi, 1976, p. 187] ne anticipava così l’uso ed il valore ‘pubblico’, ribadito oggi dalla Public History che intende contribuire all’elaborazione di nuovi modelli di sviluppo in grado di preservare, da un lato, le caratteristiche tangibili di un passato da conoscere e da assumere come valore, dall’altro, di stimolare l’attivazione di nuovi processi culturali ed economici. Ciò sarà possibile solo ammesso che si parta, piuttosto che dalla ben nota accezione di historia magistra vitae, da quella, più provocatoria, di Storia come attività produttiva e servizio pubblico. Se la prima fornisce esempi da seguire per evitare errori, la seconda fornisce ‘strumenti di lavoro’ e ‘materia prima’, da trasformare, per esempio, in attività di promozione del territorio, in itinerari e prodotti innovativi per il turismo culturale [R. Del Prete, Relazione introduttiva al Convegno Nazionale di Studi «Governance del patrimonio culturale e logiche imprenditoriali», Benevento 2012]. La storia diventa così essa stessa attività produttiva, di fondamentale importanza per il presente e per il futuro, produttrice di un bene imprescindibile per la creazione di nuove risorse, per la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile di un territorio: la conoscenza. E la valorizzazione del patrimonio culturale a fini economici, come quelli del settore turistico, passa inevitabilmente (o, almeno, dovrebbe!) attraverso la conoscenza delle risorse materiali e immateriali presenti sul territorio. Impossibile promuovere e valorizzare ciò che non si conosce a fondo: la ricerca storica, indispensabile, va collocata al primo posto della «filiera della cultura». Insomma, la governance del patrimonio culturale non può prescindere dalla ricerca storica, e l’interdisciplinarità sarà la chiave di volta. Dovranno tenerlo bene a mente gli economisti, gli aziendalisti ed i giuristi, ma anche gli ingegneri e gli architetti che intendono occuparsi di patrimonio culturale. Gli storici, gli archeologi, gli archivisti e tutti gli altri “umanisti”, dal canto loro, dovranno acquisire maggior consapevolezza del valore della ricerca storica “applicata” e non dovranno più sottrarsi né al confronto - a pari livello -, né al dialogo “multilingue” con gli esperti di marketing, di comunicazione, d’impresa, di tecnologie e di molti altri saperi. È recente, anche se decisamente “prudente”, l’elogio dell’interdisciplinarità elaborato da Pierluigi Ciocca nel suo ultimo libro, Ai confini dell’economia. Elogio dell’interdisciplinarità, Torino, Nono Aragno Editore, 2016. Attraverso una raccolta di scritti extravaganti, uno dei più colti tra gli economisti italiani, propone una nuova frontiera della ricerca economica, che esplora territori di confine fra economia, storia, diritto, politica, istituzioni, letteratura. Un approccio sempre più interdisciplinare per gli studiosi di Economics che Gianni Toniolo, nella sua recensione al volume [Il Sole 24ore, 7 agosto 2016], descrive con apprezzabile sagacia: «Ai confini della scienza economica succedono molte cose. Sono confini porosi, a due vie. Gli economisti, inquieti, fanno sempre più numerose scorribande nei territori non ben presidiati da altre scienze sociali. Si intrufolano, a volte maldestramente, nella vasta area della filosofia, discutendo di utilità e persino di felicità. Non è chiaro quanto bene abbia fatto all’economia la missione che sembra essersi data di allargarsi oltre il proprio dominio tradizionale, nel quale parecchio terreno resta ancora da dissodare. Le fa male se la porta a ignorare o minimizzare ciò che la scienza economica deve, consapevolmente o meno, a chi sta oltre i suoi confini: appunto la filosofia, la storia, la demografia, il diritto, anche la sociologia e l’antropologia, se di buona qualità». E se la posizione di Ciocca, in particolare nei confronti della letteratura, è molto critica e accusatoria - attribuendo alla letteratura italiana del Novecento l’incapacità di comprendere lo sviluppo, il sistema produttivo e le enormi trasformazioni dell’economia novecentesca -, di grande interesse sono le sue riflessioni/provocazioni sul brigantaggio nel Mezzogiorno post-unitario, così come sul linguaggio utilizzato dai “nuovi” economisti per “narrare” l’economia ai quali chiede con non poca veemenza: «Come si può pensare di pervenire al rigore geometrico, matematico, statistico, logico o che a tale rigore venga data fiducia, quando non si annette prioritaria l’importanza all’ordinary discourse nella forma e nell’efficacia persuasiva?» [P. Ciocca, 2016, pagina 177]. Agli economisti, che dalla seconda metà del Novecento hanno cominciato ad esprimersi con simboli ed esercizi econometrici, Ciocca contrappone la forza espressiva e persuasiva dei grandi romanzieri, ma anche di alcuni grandi economisti classici, Smith, Schumpeter, Keynes – per citarne alcuni - che ben seppero coniugare la storia, la politica, le istituzioni, il diritto, la statistica, le culture, coltivando in maniera egregia le sinergie con le altre branche del sapere, sempre in stretta connessione con le diverse dimensioni dell’agire umano. L’elogio dell’interdisciplinarità, spiega Ciocca parafrasando Luigi Einaudi, altro non è che la consapevolezza di una spontanea impostazione di metodo, assolutamente necessaria alla comprensione di qualunque problema economico, a sua volta «aspetto e conseguenza di un più ampio problema spirituale e morale». Ma torniamo a quell’intreccio tra scienze sociali ed economia, prima penalizzato dall’econometricità di certi orientamenti, oggi ripreso, a netto vantaggio della seconda, dalle intrusioni, talvolta maldestre, come si diceva prima, degli economisti nella storia, nella letteratura, nell’arte e nella cultura. Relazione che sta particolarmente a cuore a noi di Kinetès. Toniolo, con un’ironia sottile, ricordava le «sempre più numerose scorribande degli economisti nei territori non ben presidiati da altre scienze sociali». Forse è vero, in Italia, la “conquista”, da parte degli economisti, in particolare di molti aziendalisti, dei campi sociali, soprattutto dell’arte e della cultura, è stata favorita negli ultimi trent’anni dal fatto che i protagonisti di quei settori disciplinari fossero poco attenti a difendere i propri confini, e ancor meno intenti a superarli. Non a torto, Pierluigi Ciocca rileva nei cento romanzi italiani - selezionati da Giovanni Raboni come i più importanti del ventesimo secolo -, «una prevalente avversione nei confronti dell’economico e delle sue ricadute» (pagina 216): alla grande letteratura italiana, a differenza di quanto sia accaduto in altre culture, sono effettivamente sfuggite le enormi trasformazioni dell’economia novecentesca. Nei romanzi di Verga, Deledda, Silone, Levi e di tanti altri prestigiosi romanzieri, manca l’esaltazione della borghesia e delle sue virtù, «presupposto basilare dello sviluppo capitalistico, attraverso l’innovazione e il progresso tecnico apportati dagli imprenditori e dai capitalisti» [Ibidem]. Da qui sono poi scaturiti comportamenti sociali ed economici che hanno condizionato non poco lo sviluppo, e in tanta parte anche l’arretratezza, del nostro Paese. Troppo a lungo intellettuali, umanisti ed artisti son rimasti chiusi ciascuno nel proprio universo, isolati dalla realtà circostante e tutti intenti a percepire, imperterriti, la propria personale visione delle cose. Niente di più sbagliato! Una ricerca esoterica, troppo dettagliata, può addirittura risultare inutile se nasce da una disconnessione volontaria dal mondo. L’elitarismo accademico, quando è aperto sussiego, si irrigidisce in compartimenti stagni che fanno più il verso alla politica accademica (quella ristretta e corporativa dei vari settori disciplinari) che alla ricerca applicata e divulgativa. Appare assai pertinente riportare qui la bella metafora “naturalistica” di Piero Bevilacqua: L’albero che cresce e dà frutti non è solo il risultato del coltivatore che pianta il seme, fornisce il concime e cura lo sviluppo, ma è anche l’esito del lavoro oscuro delle radici e della chimica del suolo, del libero e gratuito irraggiamento del sole, del vento e della pioggia. E il seme piantato del coltivatore, passato di mano in mano, trasformato e reso irriconoscibile rispetto alle sue origini, è stato rinvenuto millenni addietro sulla superficie della terra, spontaneo dono della natura. Dunque, anche sotto questo aspetto, i dati naturali, manipolati nel corso del tempo dagli uomini, e perciò divenuti storici, sono protagonisti attivi della produzione materiale» [Piero Bevilacqua, Tra Natura e Storia, Roma, Donzelli, 1996, pp. 9-10]. La valorizzazione della Bellezza è altra cosa dai tecnicismi, dai conti e dalle percentuali, utili si, ma solo fino ad un certo punto: essa è armonia, condivisione, è dialogo multidisciplinare, è l’apprezzamento dei saperi, ma anche dei colori, dei suoni, dei profumi e delle emozioni. Essa è innanzitutto sensibilità, rafforzata dalla conoscenza. Uno storico rigoroso, appassionato e innovativo saprà sempre riconoscerla. E dunque, “si perdoni, a un povero studioso di storia, questo grido di artista!”. NOTE [1] Questa prima parte del testo è stata già pubblicata. Così scrivevo nel 2010, nel pregnante libricino, curato da Gaetano Cantone, che raccoglieva gli interventi dei partecipanti al Seminario del Pensiero Creativo, Materiali 2008-2009-2010, edito dall’Istituto Italiano per lo Sviluppo del Territorio.
Comments are closed.
|
Archivio
Gennaio 2023
Categorie
Tutti
Scarica qui i numeri completi della Rivista
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tutti i diritti sono riservati © Kinetès-Arte. Cultura. Ricerca. Impresa. 2016 |
|

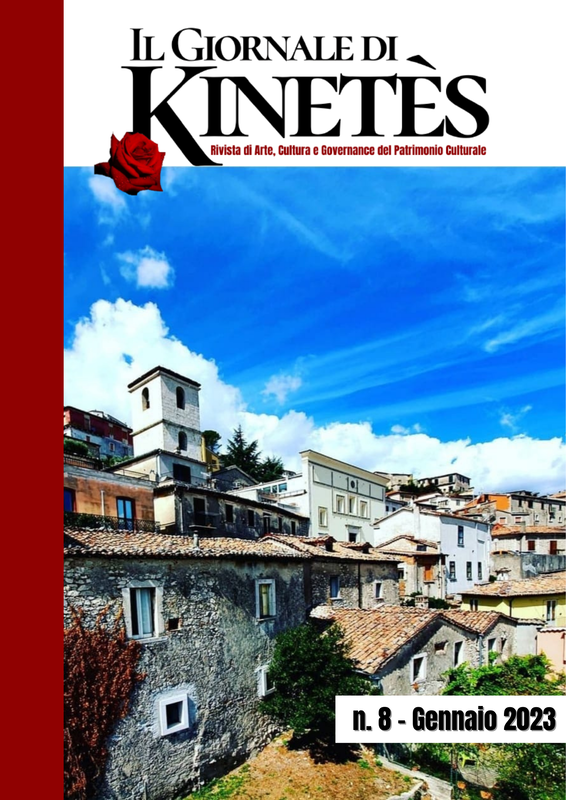
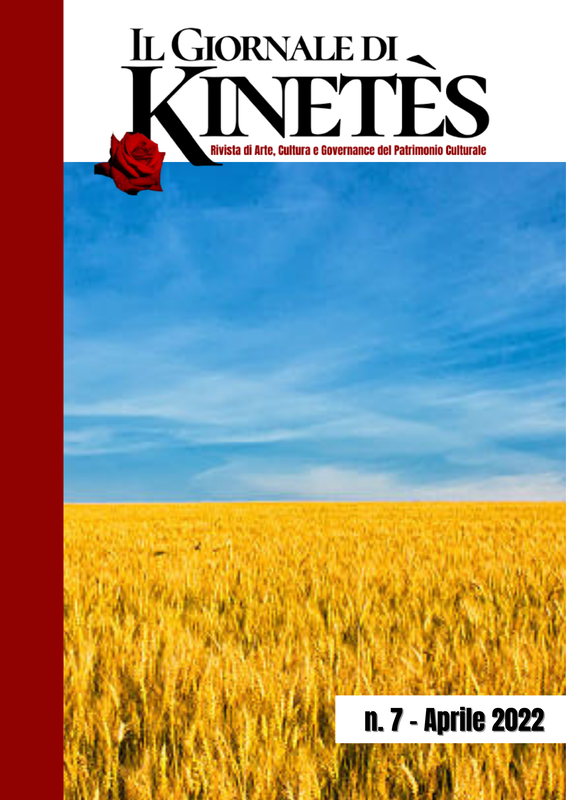
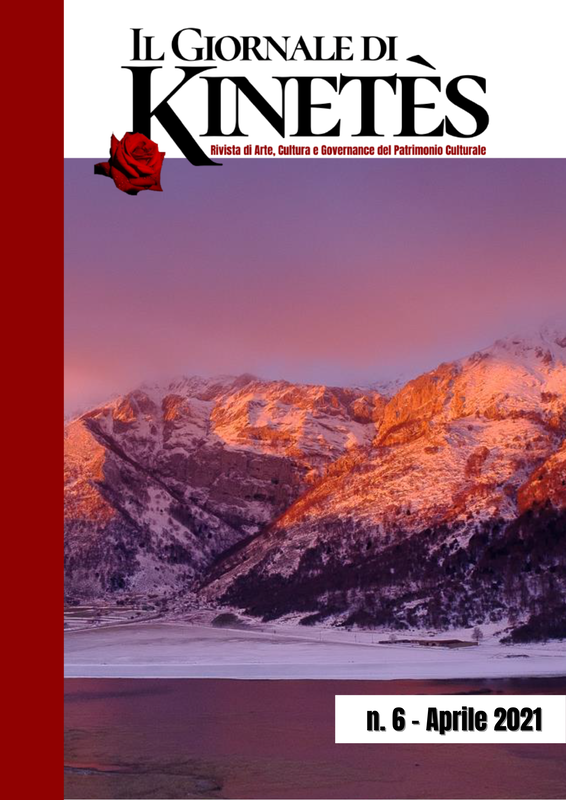
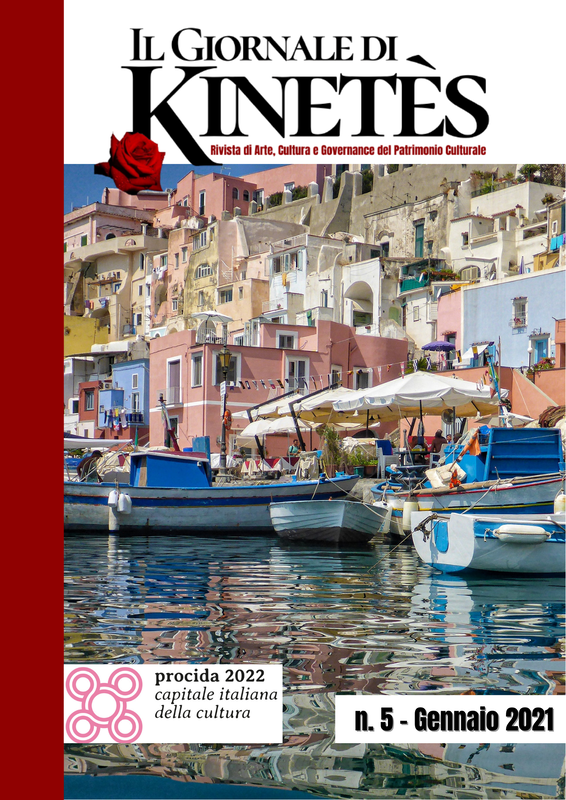
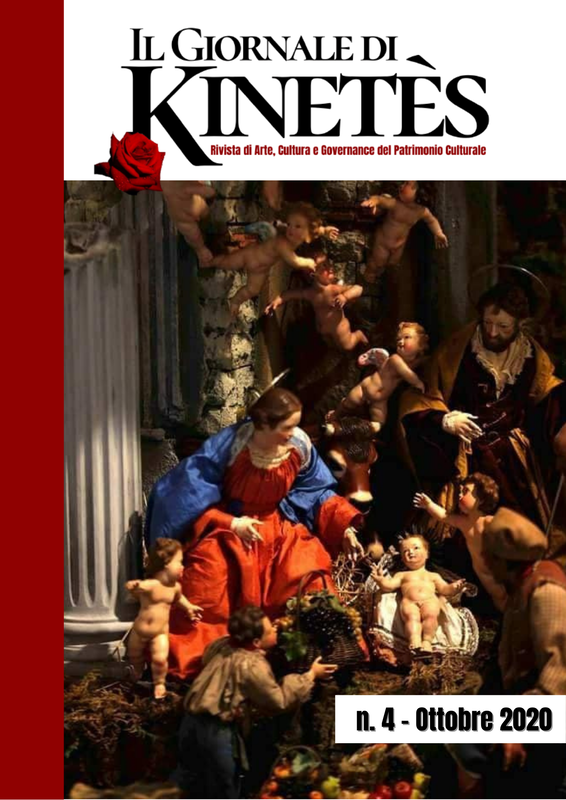

 Feed RSS
Feed RSS

