di Concetta Nazzaro Il valore del Made in Italy agroalimentare Il settore agroalimentare italiano risulta caratterizzato da un elevato numero di imprese di piccole dimensioni e da un ridotto numero di grandi imprese operanti su scala globale. Esso rappresenta un comparto di punta dell’economia italiana, posizionandosi al secondo posto tra quelli manifatturieri per ciò che concerne l’export, e con una miglior capacità di resilienza a fronte della crisi da Covid-19. Al contempo, il patrimonio agroalimentare italiano, per il suo ampio e differenziato portafoglio di prodotti, caratterizzati da un forte contenuto di tipicità, risulta tra i più competitivi sui diversi mercati, proprio in virtù della presenza di apprezzati attributi di qualità e di sicurezza alimentare. In generale, i prodotti agroalimentari possono essere contraddistinti da marchi, di natura individuale o collettiva, da etichette e indicazioni per la tracciabilità, nonché da indicazioni sull’origine e/o la provenienza, che si identificano con la dicitura “Made in…”, regolate da apposite leggi nazionali ed europee. L’obiettivo è quello di tutelare il cittadino-consumatore da informazioni erronee e mendaci. In particolare, con riferimento ai prodotti a marchio DOP (Denominazione di Origine Protetta) e IGP (Indicazione Geografica Protetta) è prevista l’obbligatorietà dell’origine in etichetta essendo le qualità di tali produzioni, la loro lavorazione e trasformazione legata proprio a un particolare ambiente geografico e saper fare artigianale locale. Dunque, il Made in Italy agroalimentare identifica quei prodotti che risultano fortemente legati all’identità culturale e artigianale del bel Paese. Essi rappresentano una rilevante quota dell’esportazione dell’intero settore, e per tale motivo sono anche oggetto di fenomeni di agro-pirateria e del c.d. italian sounding, ovvero di imitazioni, falsificazioni e contraffazioni di marchi, denominazioni e immagini che evocano il luogo d’origine (si tratta di un fenomeno così diffuso da arrivare a sottrarre al nostro export, secondo le stime, ben 60 miliardi di euro annui). È ampiamente riconosciuto che, in particolar modo nel corso degli ultimi anni, l’indicazione Made in Italy abbia ottenuto una discreta appetibilità commerciale e che qualsiasi prodotto etichettato come tale acquisisca immediatamente un valore aggiunto e un vantaggio competitivo sui mercati nazionali e internazionali. Si tratta, infatti, di un comparto strategico per il sistema Paese: da un’analisi Coldiretti (2022) si osserva come il Made in Italy agroalimentare rappresenti un giro d’affari capace di coinvolgere circa 740.000 aziende agricole, oltre 330.000 realtà ristorative, ben 230.000 punti vendita al dettaglio, 70.000 industrie alimentari e 4 milioni di lavoratori in tutto il Paese. Nel 2020 il valore del Made in Italy agroalimentare è stato pari a 522 miliardi di euro, arrivando a rappresentare ben quindici punti percentuali del PIL nazionale. A trainare la crescita del Made in Italy nel mondo sono i prodotti base, in particolar modo il vino che guida, da sempre, la classifica dei prodotti più esportati, seguito dall’ortofrutta fresca. Quanto alle esportazioni, il 2022 ha rappresentato un anno significativo, segnato dalla registrazione di un record storico per il Made in Italy agroalimentare, che è cresciuto del 21,5% rispetto all’anno precedente. Tale crescita ha coinvolto anche il canale e-commerce, che ha registrato +17%, accelerazione probabilmente dovuta ai cambiamenti intervenuti nelle modalità di acquisto che hanno coinvolto i cittadini-consumatori durante il periodo di lockdown. Il principale mercato di sbocco estero è rappresentato dalla Germania, in aumento del 12,4% rispetto al 2021, seguita dagli Stati Uniti, che presentano una crescita del 21,5%, e dalla Francia (+19,5%). Ma il vero boom di vendite si è verificato nel Regno Unito, con un +32,5% rispetto al 2021, anche se pesa il crollo del 25,1% in Cina e del 41,2% in Russia. Quanto ai prodotti agroalimentari DOP e IGP nell’UE, sulla base dei dati evidenziati dal rapporto ISMEA - Qualivita (2021), l’Italia continua a detenere il primato con 312 prodotti registrati e 3 Specialità Tradizionali Garantite (STG). I produttori, 82.000 unità, sono impegnati in modo più consistente nei settori dei formaggi (27.412), oli d’oliva (22.356), ortofrutta e cereali (18.163). I trasformatori, 7.503 in totale, sono impegnati, in particolar modo, nei settori degli oli (1.984), formaggi (1.433), ortofrutta e cereali (1.372). Il valore della produzione agroalimentare a marchio, invece, ha sfiorato in Italia, nel 2021, i 7,7 miliardi di euro, con una crescita su base annua pari al 5,7%. Un discorso a parte merita il vino DOP e IGP, produzione di punta del Made in Italy agroalimentare, che con i suoi 526 prodotti DOP e IGP registrati in Italia, e una produzione imbottigliata, nel 2021, pari a 3,2 miliardi di bottiglie (con una crescita del 4,1% su base annua), presenta un valore della produzione che supera i 9 miliardi di euro ed un valore all’export pari a circa 6 miliardi di euro. Riguardo la distribuzione territoriale italiana della produzione agroalimentare di qualità, tra il Nord ed il Sud del Paese si registrano dinamiche ancora asimmetriche: prosegue, infatti, il trend positivo degli operatori nel Mezzogiorno, che crescono del 4,8% rispetto al 2021. Al contrario, si osserva un calo consistente degli operatori al Nord, pari a -9%. Quanto ai produttori, la maggiore incidenza, a livello territoriale, si riscontra, come noto, nel Mezzogiorno, nell’ambito del quale si concentra oltre il 41% del totale, mentre il Nord Italia si caratterizza per la maggiore concentrazione di trasformatori (40,7%). Più equilibrata la distribuzione degli operatori al Centro, che, nel complesso, incidono per il 22% (in misura stazionaria rispetto all’anno precedente), con percentuali più equilibrate tra produttori (pari al 22,1%) e trasformatori (pari al 25,2%). Il ruolo delle donne nell’agroalimentare italiano e nel recupero delle aree interne Il successo riscontrato dal Made in Italy agroalimentare ha le sue basi nella elevata qualità intrinseca delle produzioni che riguarda, essenzialmente, le caratteristiche organolettiche dei prodotti e le materie prime utilizzate, oltre che nella qualità percepita dai cittadini-consumatori. È proprio il valore attribuito agli aspetti immateriali (recupero del territorio di origine, delle tradizioni, della qualità ambientale ed etica…) di tali prodotti che, negli ultimi anni, ha generato una crescita della domanda di consumo, in linea con le nuove sensibilità e istanze sociali in tema di ambiente e qualità della vita. Attributi che, dunque, sono stati al centro di strategie di riposizionamento competitivo nell’ambito di modelli di diversificazione produttiva e aziendale che hanno trovato spazio in un percorso di ricambio generazionale e di genere nell’agricoltura, soprattutto, del Mezzogiorno d’Italia. Infatti, dalle stime recenti ISMEA (2021), CREA (2022), nonostante il persistere della crisi economico-finanziaria accentuata dalla pandemia, il settore agroalimentare è quello che ha mostrato una migliore capacità occupazionale femminile proprio in forza della loro capacità di saper affrontare le nuove sfide e intercettare i cambiamenti in atto, mostrando una maggiore propensione ad accogliere e implementare processi di innovazione sociale e sostenibilità ambientale in ambito aziendale. Le imprese attive condotte al femminile in agricoltura sono, ad oggi, 204.214. Il maggior numero in assoluto di imprese agricole femminili si rileva in Sicilia (24.831 realtà aziendali, +1,7 negli ultimi due anni), seguita da Puglia (23.361) e Campania (21.406). A livello provinciale, invece, emergono Trieste, con un incremento del 6,92%, Lecce (+6,59%) e Como (+5,48%). Secondo i dati dell’Ente Bilaterale Agricolo Nazionale, aumentano, nel settore, lievemente anche le lavoratrici dipendenti: impiegate, quadri e dirigenti, che raggiungono il 47% degli occupati; mentre le operaie rappresentano il 32% del totale. Le lavoratrici straniere sono, invece, complessivamente, il 24%, di cui il 39% comunitarie e il 17% extra comunitarie. Inoltre, mostrano particolare dinamismo le donne impegnate nelle società di capitali e di persone che, nella fascia di età 18-29 anni, raggiungono il 33,76%. Questo dato risulta particolarmente significativo, se consideriamo che dieci anni fa erano meno della metà e rappresentavano il 14% del totale. Ma vale la pena evidenziare che secondo uno studio Confagricoltura (2022), le imprenditrici agricole sono più propense a introdurre forme di diversificazione produttiva e attività di educazione ambientale e alimentare nell’ambito della multifunzionalità agricola. Coerentemente, si rileva una crescita della presenza femminile nelle attività di filiera corta, con una particolare resistenza dello zoccolo duro dell'agriturismo e delle fattorie didattiche (che sono arrivate complessivamente al 60%), a cui, negli ultimi anni, si sono affiancate in maniera significativa le fattorie sociali. Queste ultime che svolgono la funzione di care farm, ovvero forme di agricoltura inclusiva e rigenerativa, rappresentano meglio le (nuove) funzioni sociali dell’agricoltura a vantaggio di modelli produttivi comunitari, etici e solidali baluardo, oggi, delle aree interne del Mezzogiorno. Negli ultimi dieci anni, inoltre, risulta fortemente cresciuta, in percentuale, la presenza femminile oltre che nelle aziende zootecniche, superando il 43%, in quelle floricole femminili sfiorano il 50%. Un dato particolarmente interessante riguarda, poi, il comparto del biologico: delle quasi 50.000 imprese agricole biologiche presenti in Italia, circa il 30% sono condotte da donne. Tale dato contribuisce a dimostrare la tendenza delle donne a rendere l’agricoltura più sostenibile, grazie alla loro naturale propensione all’innovazione e alla multifunzionalità. Esse, infatti, non percepiscono l’azienda solo come fonte di reddito, ma come motore di nuovi processi di sviluppo sostenibile e inclusivo del territorio, nell’ambito di un modello di agricoltura trasformativa e generatrice di nuove relazioni in grado di presidiare quei territori e quelle aree oggi più ricche di risorse ambientali, identitarie e sociali ma maggiormente a rischio. Pertanto, proprio in virtù delle caratteristiche appena illustrate, le donne possono svolgere un ruolo cruciale anche nel perseguimento degli obiettivi europei in tema di twin transition e diffusione di innovazioni collettive sostenibili. Un sostegno dovrà arrivare, però, anche dalle politiche, che avranno il compito di continuare a incentivare il primo insediamento delle donne in agricoltura, migliorare i programmi di assistenza tecnica per supportare le imprese femminili e, in ultima istanza, disegnare misure mirate a supportare lo sviluppo delle imprese agricole femminili nei comparti del Made in Italy. Conclusioni In sostanza, la transizione verso modelli di agroalimentare sostenibile che rafforzino la competitività del Made in Italy va inquadrata necessariamente anche in ottica territoriale, ovvero di inclusione di tutte quelle realtà spaziali, oggi ancora escluse (aree interne), che rappresentano i luoghi di origine, anche culturale, del patrimonio di prodotti a marchio. L’agricoltura e l’agroalimentare italiano in forme organizzative e di business decisamente nuove rispetto al passato si configurano, oggi, come le principali leve per costruire prospettive rigenerative dei territori di riferimento e invertire i processi di ritardo e di desertificazione tuttora in atto. In questa nuova prospettiva, le aree rurali/interne da “non luoghi” si trasformano in spazi di opportunità, in “luoghi identitari” in cui diventa possibile per le comunità territoriali costruire economie locali generatrici di valori materiali e immateriali, orientate al benessere e alla qualità della vita (Nazzaro; 2021; Marotta, Piazza, 2021). Infatti, grazie alla capacità di interpretare le nuove sensibilità sociali -rispetto ai temi dell’ambiente e della sua relazione con la salute, dei cambiamenti climatici, del rapporto alimentazione e salute, della necessità di spazi di socializzazione e di vivibilità- le aree interne si sono trasformate da luoghi di sola produzione anche a spazi di consumo e di fruizione, e presentano oggi ampie potenzialità per dare risposta alle domande di benessere e di qualità della vita dei cittadini-consumatori. L’agroalimentare, dunque, si pone al centro di questo processo di rinnovamento economico-sociale, contribuendo a modellare i “territori di origine” secondo una caratterizzazione coerente con le nuove domande e re-interpretando i bisogni sociali in ottica egualitaria e inclusiva, secondo inedite linee di evoluzione strutturale e organizzativa. Comments are closed.
|
Archivio
Gennaio 2023
Categorie
Tutti
Scarica qui i numeri completi della Rivista
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tutti i diritti sono riservati © Kinetès-Arte. Cultura. Ricerca. Impresa. 2016 |
|

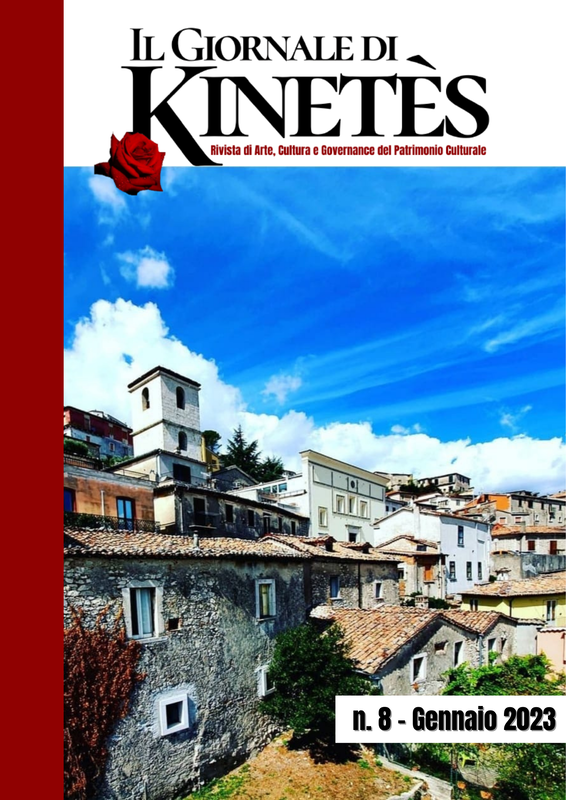
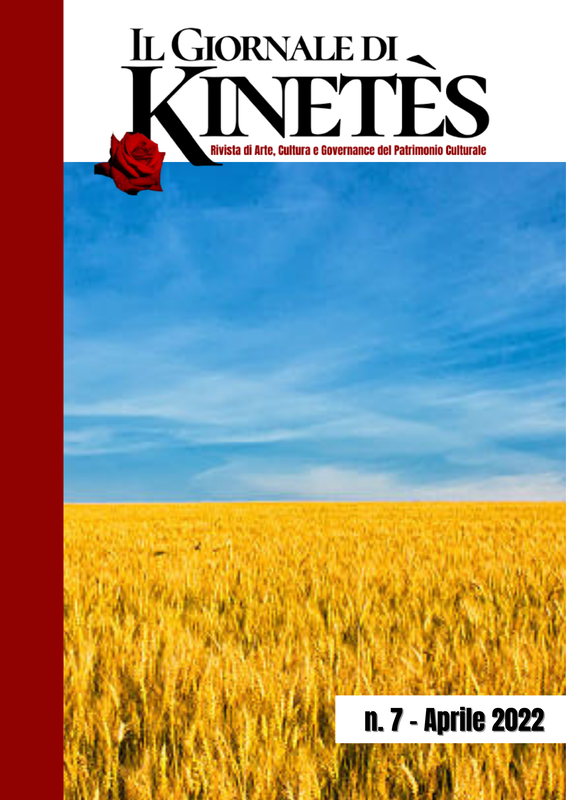
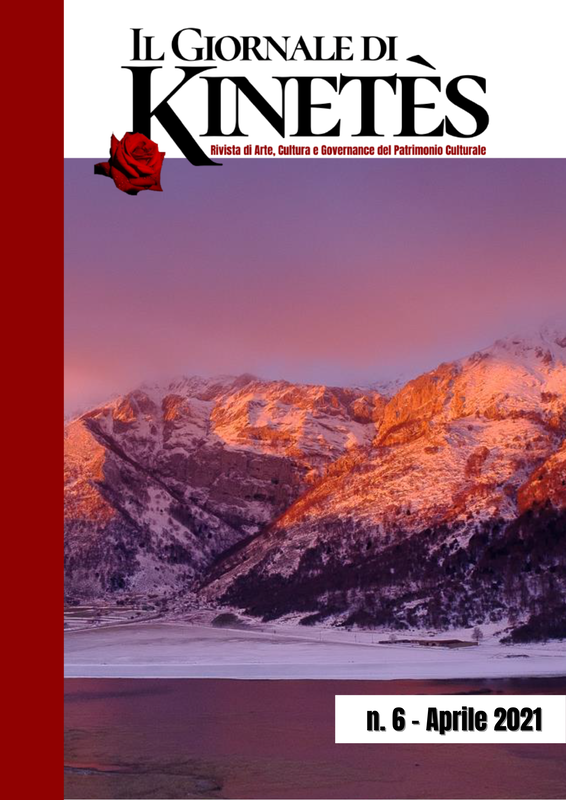
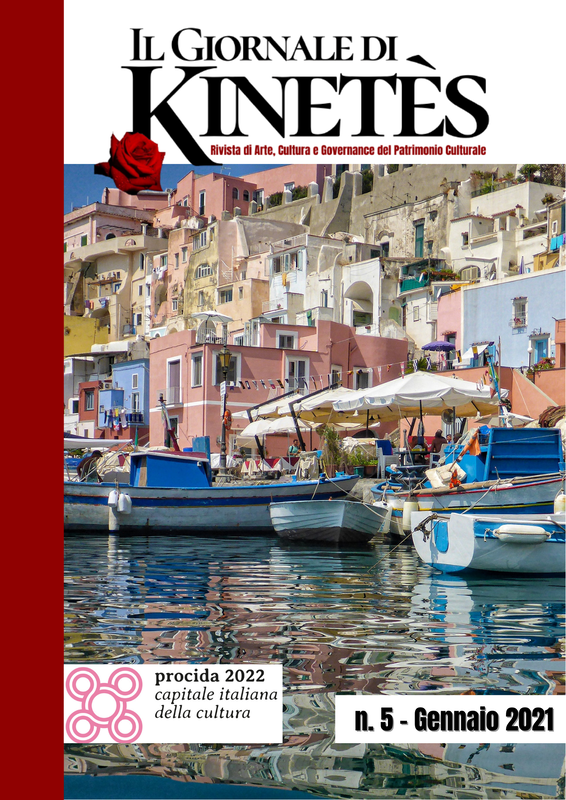
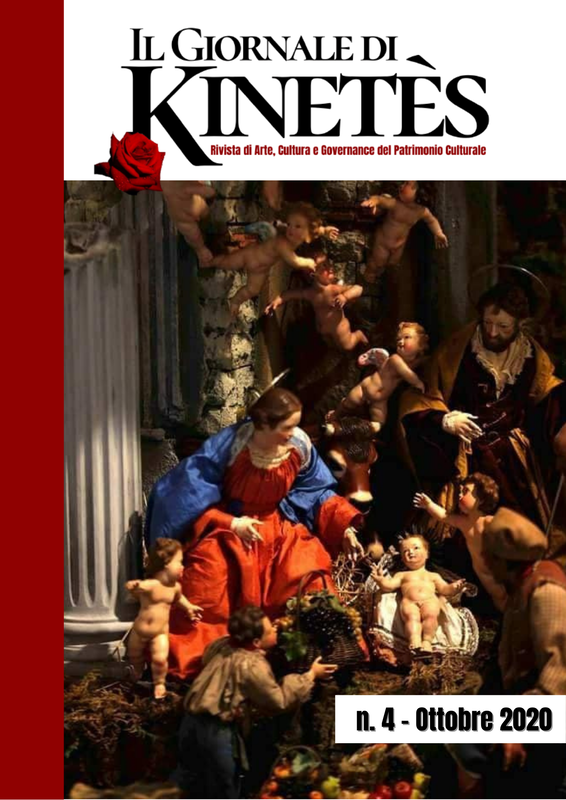

 Feed RSS
Feed RSS

