|
Quarant’anni fa, nel 1957, Luciano Bianciardi pubblicava Il lavoro culturale, per i tipi dell’Universale Economica Feltrinelli. Bianciardi era ben noto al pubblico dell’intellighenzia militante di quegli anni, per la sua intensa attività culturale, svolta nell’ottica di un impegno civile e politico già profuso in altri suoi libri. Ne Il Lavoro culturale l’Autore affidava uno dei primi resoconti critici della generazione del dopoguerra a due personaggi, opposti quanto complementari: Luciano Bianchi, calciatore mancato e antifascista, ed il fratello Marcello, intellettuale militante di provincia. Il romanzo racconta, con sapiente ironia, la storia di quest’ultimo, che incarna il prototipo dell’intellettuale impegnato degli anni Cinquanta. Fermamente convinto della forza emancipatrice della cultura ed aspirante educatore delle masse, Marcello è impegnato a sperimentare le forme dell’organizzazione culturale tipiche del secondo dopoguerra. Dopo aver condiviso il campo di battaglia con gruppi di contadini analfabeti suoi coetanei, lui che si era arruolato come ufficiale, si convince che la cultura, quella che lui possiede grazie al privilegio di classe, «non ha senso se non ci aiuta a capire gli altri, a soccorrere gli altri, ad evitare il male». Eccolo, dunque, continuamente impegnato in un’inesauribile attività di organizzazione di cineforum, seminari, presentazioni e dibattiti, mentre ‘in agguato’ si preparano almeno due minacce: la rigida e stereotipata ortodossia del partito comunista e la nascente industria culturale e, con essa, l’organizzazione di un mercato dell’arte, della cultura, della conoscenza e persino dell’anima! A distanza di quarant’anni, l’Italia è un Paese diverso: non vi sono più partiti di massa né ideologie, non vi è più relazione tra cultura e politica e, probabilmente, non esiste più neppure il ceto degli intellettuali, quello che Zygmunt Bauman investiva del ruolo di “legislatore”. L’educazione delle masse non è più affidata ai cineforum, ai seminari e ai dibattiti, ma ai social e alla televisione. Resta forse valida, almeno in nuce, quella consapevolezza che animò l’attivismo di Marcello: «la cultura non ha senso se non ci aiuta a capire gli altri, a soccorrere gli altri, a evitare il male». Kinetès – Arte.Cultura.Ricerca.Impresa. è nata con questi intenti e, per sintetizzare con più efficacia il concetto, si è data un motto: La Cultura, non sostenuta dal buon senso, è raddoppiata follia (B. Gracian). Ed è piena follia quella a cui oggi spesso assistiamo quando sprechiamo talenti e professionalità costruite in anni e anni di percorsi formativi universitari, di alta formazione e specializzazione post universitaria e di esperienze professionali accumulate (male) in anni e anni di precariato. Il lavoro culturale, oggi, è certamente cosa diversa da quello raccontato da Bianciardi, per una lunga serie di ragioni. Due, tra le più recenti, potranno avviare meglio la riflessione: la legge 110/2014, con cui lo Stato italiano riconosce solo alcune delle professioni del Settore Culturale (archeologi, archivisti, bibliotecari, storici dell’arte, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica, di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali), ignorandone altre oggi sempre più indispensabili (tecnico museale e divulgatore per i beni culturali, esperto d’informatica per le discipline umanistiche e i beni culturali, manager dell’arte e della cultura, mediatore culturale museale) e la Riforma del Terzo Settore, con cui lo stesso Stato italiano affida, di fatto, le specificità del lavoro culturale ai volontari. Viviamo nel Paese con la maggior presenza di siti Unesco, con una straordinaria offerta di siti storico-artistici, musei, teatri e sale da concerto, con oltre 413.752 imprese culturali e creative e quasi 1.500.000 addetti, eppure, stentiamo a decollare nel settore turistico-culturale. Perché? Forse perché gli addetti al settore culturale ed a quello turistico hanno ancora livelli d’istruzione poco significativi? Forse perché questi stessi addetti non possono contare su un bagaglio di esperienze e di competenze gestionali adeguate al mercato? Forse perché gli Italiani, in generale, consumano molto meno in Cultura? Forse perché il patrimonio culturale italiano è quasi esclusivamente “gestito” dalla Pubblica Amministrazione? Forse perché in Italia siamo ancora convinti che, poiché la Cultura è un bene comune, non sia necessario gestirla con professionalità e logiche imprenditoriali? Le domande potrebbero continuare all’infinito, ma la risposta sarebbe sempre la stessa: il Comparto della Creatività, della Cultura e del Turismo Culturale ha la necessità di essere affidato ai professionisti del settore, quegli stessi professionisti, che lo stesso Stato italiano forma oggi, richiedendo loro sempre maggiori investimenti in tempo e denaro da spendere in corsi di laurea, corsi post-laurea, esperienze all’estero, competenze linguistiche e lunghi, estenuanti e sempre più costosi stage formativi. Peccato che poi, lo stesso Stato, dimentichi di ‘riconoscerne’ la imprescindibile necessità! Intanto, nel Paese dei paradossi, piuttosto che intraprendere strade per ottimizzare l’impiego concreto dei tanti giovani (e ormai anche meno giovani) formati ad hoc come professionisti della cultura, ci si entusiasma di fronte al successo, per esempio, di un evento come quello delle Giornate Fai di Primavera. Un evento organizzato da una Fondazione Privata che, grazie al coinvolgimento di un esercito di volontari (di estrazione professionale e culturale molto, ma molto eterogenea!), riesce comunque a coprire le spese di un organico fisso e a trovare i fondi per gestire patrimonio culturale pubblico o privato che riesce ad ottenere in donazioni e affidamenti, in un complesso sistema di persuasione e compiacimenti politici e sociali, in cui lo stesso Stato garantisce il più massiccio contributo pubblicitario che abbia mai concesso persino alle attività propriamente istituzionali (si pensi al contributo della RAI alla promozione delle Giornate FAI). Sarà allora il caso di porsi una domanda: perché aprire oltre 1.000 beni culturali all’anno in sole due giornate, affidandone l’apertura ai volontari del FAI, e non garantirne l’apertura, la gestione, la manutenzione e la rigenerazione continue, affidandoli ad imprese culturali disposte ad investire risorse proprie nel Settore? E’ davvero curioso che l’attenzione dei rappresentanti istituzionali e dei cittadini italiani - che si mobilitano in quei due soli giorni per visitare luoghi per i quali non hanno mai mostrato interesse prima -, esploda soltanto in occasione dell’evento FAI. Sarà che i comportamenti sociali sono influenzati dalla pubblicità martellante? Sarà che c’è una certa necessità di confondere le idee dei cittadini? Sarà che è più comodo pensare che sia qualcun altro a prendersi la briga di organizzare un sistema di raccolta fondi e di volontari ‘appassionati’? E, per estensione, sarà che il volontariato culturale e la Riforma del Terzo Settore sono l’ennesimo blando tentativo di applicare un ammortizzatore sociale alla dilagante disoccupazione di giovani sempre più “titolati” e l’ennesimo tentativo di colmare il vuoto di responsabilità istituzionale nell’assolvimento di compiti e funzioni ordinarie per lo Stato? Se è così, allora forse hanno ragione gli attivisti del Movimento per il Patto del Lavoro Culturale quando affermano: «Le giornate FAI di Primavera non sono una festa. Sono un cerotto alla buona, pur utile, su una ferita che continua incessantemente a sanguinare». Ma ‘sparare’ sul FAI è un po’ come sparare sulla Croce Rossa…o sulla Caritas…e non è nostra intenzione confutare l’importanza di un’operazione culturale così imponente come quella messa in atto dal Fondo per l’Ambiente Italiano o da qualunque altra piccola o grande associazione culturale: il coinvolgimento dal basso è importantissimo e qualunque sollecitazione a fruire del nostro immenso patrimonio culturale è dovuta. Ciò che sentiamo di dover fare è piuttosto una difesa incondizionata e profondamente consapevole delle professioni della cultura e del turismo e della necessità di avvalersene con incarichi precisi, regolarmente e degnamente retribuiti. E se è vero che il problema è creare un contesto di esperienze accessibili che consentano di dare valore e significato al bene culturale, nella sua accezione più ampia, è ancor più vero che, se si continua a veicolare il messaggio che chiunque possa occuparsi di cultura e di turismo culturale, non riusciremo mai ad innescare quella interazione sinergica tra domanda e offerta o tra formazione e occupazione, necessaria alla creazione di un’economia virtuosa, in cui il fruitore/acquirente abbia piena consapevolezza del valore del patrimonio culturale, ma anche dei suoi costi di manutenzione, di gestione e di valorizzazione – costi materiali e costi umani, che non possiamo più far finta che non esistano o che debbano essere tutti a carico dello Stato. Inoltre, il Settore Culturale soffre del solito pregiudizio “intellettualistico” che guarda con sospetto ad ogni investimento delle imprese nella cultura, che mostra diffidenza e superiorità di fronte agli studi umanistici, alle competenze specifiche del settore artistico culturale, rinnegando, inconsapevolmente, percorsi di studio in cui, nonostante tutto, lo Stato investe la sua (modesta) spesa per l’istruzione, continuando a formare competenze che non troveranno poi posto nel mercato del lavoro culturale. È il caso di ricordare il bando appena pubblicato per la selezione di 47.529 volontari del Servizio Civile e quello per i 1.000 volontari bandito direttamente dal MIBACT. Quest’anno arriveremo ad oltre 50 mila volontari (15 mila in più dello scorso anno) e l’obiettivo del governo è quello di arrivare a 100mila volontari entro il 2020. Vanno poi ricordati i finanziamenti stanziati sul progetto europeo Garanzia Giovani, anche quelli spesso utilizzati per finanziare il reclutamento di volontari del servizio civile, anziché per contrastare la disoccupazione giovanile. E troppo spesso si ripete “non è lavoro, è Servizio Civile”, dimenticando che un bibliotecario, un archivista, un archeologo, uno storico dell’arte, un ballerino o un orchestrale…hanno pieno diritto, dopo l’investimento fatto in formazione, ad esercitare un lavoro regolarmente e adeguatamente retribuito, che sia riconosciuto innanzitutto come lavoro piuttosto che come “dovuto” servizio civile. Ogni lavoro ha il suo valore etico pubblico e può dunque essere considerato servizio civile, ma in quanto lavoro va sempre riconosciuto e remunerato! Paradossalmente, il settore più promettente della nostra economia, quello dei beni culturali, pare sia diventato un campo di sperimentazione per nuove forme di lavoro sottopagato, dagli scontrinisti all’utilizzo improprio del servizio civile, fino alla sostituzione dei professionisti del settore, con volontari non pagati, ai quali oggi, subdolamente, vengono spesso associati persino gli studenti delle scuole superiori obbligati a seguire progetti di alternanza scuola/lavoro. Un mercato del lavoro culturale costruito ad arte, in cui il blocco del turnover ed il patto di stabilità impediscono nuove assunzioni e costringono sempre più spesso gli enti pubblici ad attingere a piene mani allo straripante serbatoio del volontariato. E, quando va bene, tra i volontari si ‘pescano’ quelli preparati a compiere specifiche mansioni del lavoro culturale; quando va male - nella stragrande maggioranza dei casi -, attuare progetti del Servizio Civile diventa l’unico modo per poter contare su un personale che garantisca l’offerta dei servizi necessari, qualunque siano formazione e competenze. Nel frattempo, un’enorme quantità di personale, formato e specializzato, viene lasciato a casa, producendo un enorme e irreparabile danno collettivo. C’è da andarne fieri? Kinetès – Arte.Cultura.Ricerca.Impresa. crede di no e da tempo ha aperto un dibattito acceso e frequente su questi temi. L’ultimo, in ordine di tempo, si è svolto lo scorso 20 giugno presso l’Università degli Studi del Sannio: ««Impresa culturale profit o non profit? Professionisti o Volontari? L’impatto economico dell’impresa culturale ed il suo impatto sull’economia del territorio: alto contenuto di conoscenza, multidisciplinarietà, professionalità e varietà nei settori di applicazione».
Comments are closed.
|
Archivio
Gennaio 2023
Categorie
Tutti
Scarica qui i numeri completi della Rivista
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tutti i diritti sono riservati © Kinetès-Arte. Cultura. Ricerca. Impresa. 2016 |
|

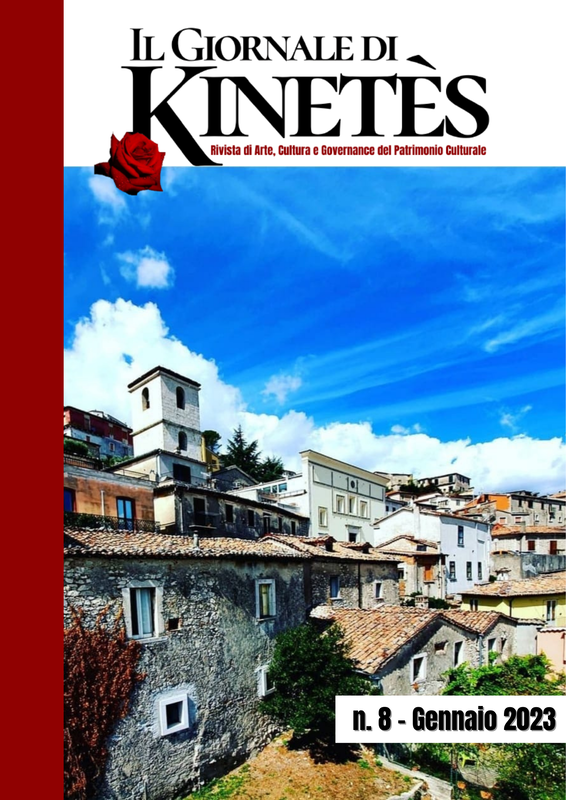
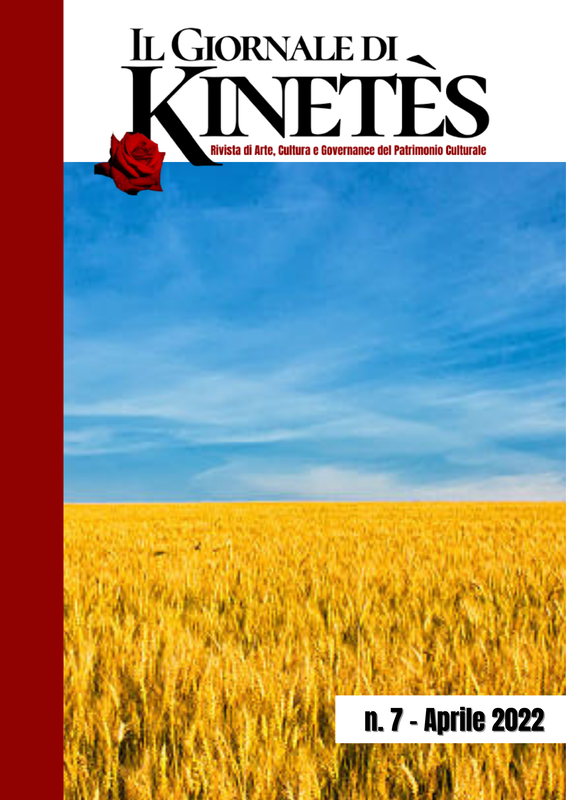
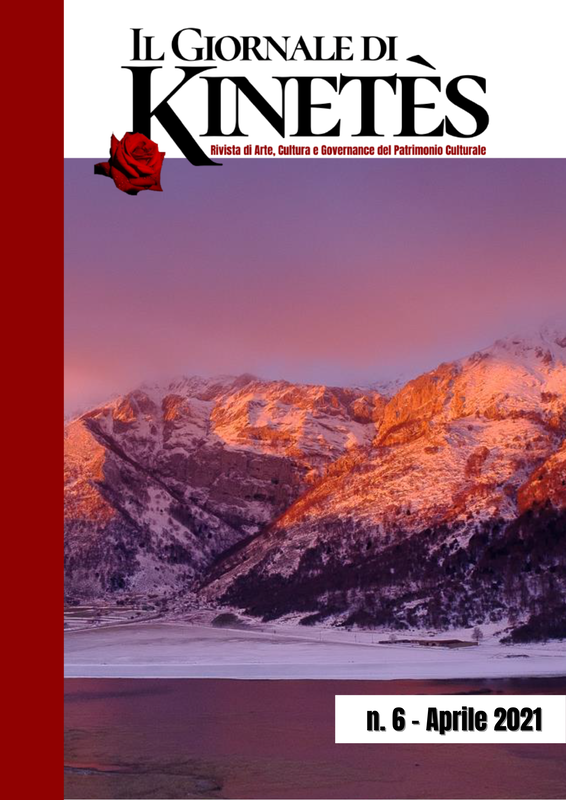
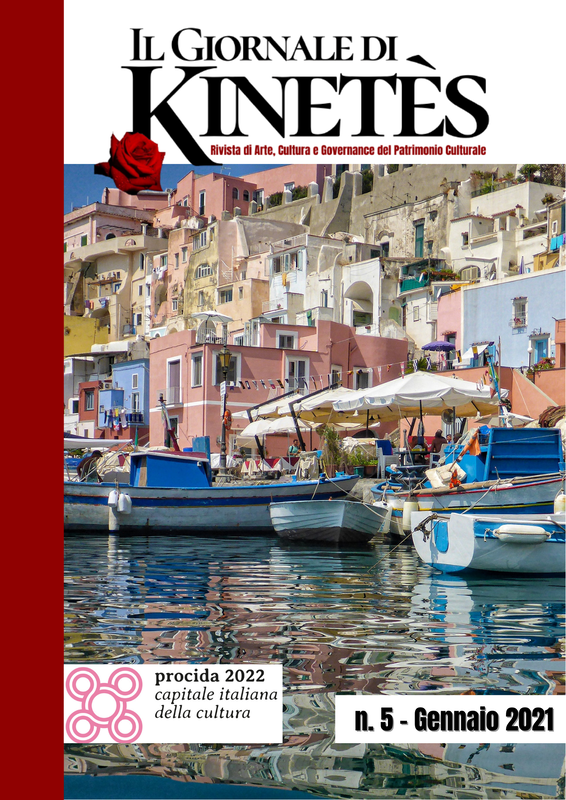
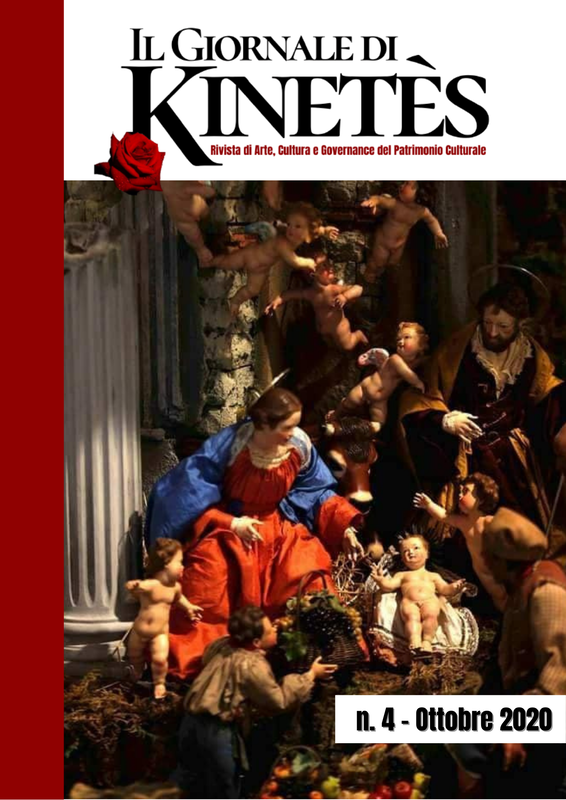

 Feed RSS
Feed RSS

