|
di Federico Marazzi Quanto in Italia l’archeologia medievale abbia patito per affermarsi come disciplina autonoma e accademicamente riconosciuta, è storia nota. Per molti motivi, nel nostro Paese lo studio del Medioevo archeologico non ha storicamente riscosso lo stesso interesse e lo stesso supporto tributato all’archeologia dell’età classica. Sicuramente, in tal senso ha giocato il fatto che l’Italia è stata la patria del Rinascimento, e cioè dell’idea che il tratto temporale trascorso fra la crisi e la fine dell’Impero Romano e il momento in cui il Rinascimento stesso fiorì, avrebbe costituito una media aetas, cioè un’età di mezzo in cui la civiltà aveva conosciuto un lungo periodo di declino, perdendo le capacità – ma anche le sensibilità – necessarie a riprodurre il bello nelle arti e nella letteratura. Questa fase comprendeva – grosso modo - l’intervallo fra il momento in cui si era conclusa la fase di apogeo dell’Impero Romano (la fine del II secolo d.C.) e il XV secolo, e cioè quel lungo periodo che oggi gli storici denominano Tarda Antichità e Alto Medioevo. 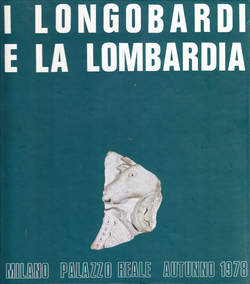 L’allontanamento dai canoni di perfezione e armonia che avevano caratterizzato il periodo classico (definito tale, appunto, perché paradigmatico nel suo aver costituito l’Occidente aveva guadagnato il primato culturale che il Rinascimento intendeva ripristinare) era stato tale che anche l’arte del periodo immediatamente precedente quello rinascimentale, nel Cinquecento fu spregiativamente definita “gotica”, pur essendo temporalmente assai lontano da quello in cui in Europa fu presente la popolazione germanica nota con tale nome. Con questa definizione s’intendeva sottolineare la distanza (e quindi il loro evidente imbarbarimento) delle forme artistiche che allora si erano prodotte rispetto quelle che avevano invece caratterizzato l’età antica (Kidson 1996). Questo stigma estetico si è in breve traslato su un terreno di carattere storico-politico dal momento che, già nel corso del XVI secolo, si notò che il periodo di “decadenza” dell’arte corrispondeva con quello in cui l’Italia aveva smarrito non solo il suo primato culturale, bensì anche quello politico per poi infine perdere anche l’indipendenza (Tafuro 2012). Con queste premesse, si può ben comprendere come l’attenzione e lo studio e la riproduzione dell’arte classica, delle sue opere e dei suoi canoni abbiano rappresentato un elemento identitario della cultura italiana, che ritrovava in nel passato che essa testimoniava un collante in grado di giustificare la possibilità stessa che la Penisola potesse essere considerata qualcosa in più che una mera “espressione geografica”. È impossibile in poche righe riassumere un dibattito lungo di secoli e che ha visto coinvolti nomi tra i più importanti della cultura italiana, ma va ricordato che fu solo all’inizio del XVIII secolo che iniziarono a levarsi voci, come quella di Ludovico Antonio Muratori, che cercarono di analizzare il Medioevo in un’ottica di continuità e non di contrapposizione al lascito dell’Antichità (Marri 2013 e s.a.). In particolare, Muratori, teorizzò che il presente di divisione interna e di forte regionalizzazione dei destini politici delle varie aree d’Italia – un dato di fatto che, piacesse o no, aveva comunque finito per marcarne indelebilmente i connotati – poggiava comunque sull’eredità lasciata dall’Antiqua Mater rappresentata dal comune passato che, per ciascuna di esse, affondava nel tempo in cui tutta la Penisola era stata unificata sotto le insegne di Roma. Anche il tema dell’ingresso sul territorio italiano delle popolazioni germaniche, quali Goti e, soprattutto, Longobardi, venne in quest’ottica riesaminato da Muratori – per la prima volta – attraverso un’attenta escussione delle fonti storiche, portandolo ad interpretarlo come un evento “rigenerativo” della storia italiana, della quale i “barbari” gli apparvero come i redattori di un capitolo interamente nuovo, anche se apertosi non senza durezze e difficoltà (Artifoni 2000). La posizione di Muratori, qui assai sinteticamente riassunta, esercitò sicuramente molto influsso sulla storiografia italiana del secondo Ottocento, quando ci si trovò alle prese con il complesso tema della conciliazione fra l’esigenza, concretamente pressante, di promuovere contenuti culturali in grado di cementare la precaria costruzione della recente unità nazionale, e quella speculare di far convivere i primi con le storie e le memorie delle realtà locali. Un’operazione che, come sappiamo, da un lato produsse la creazione dell’Istituto Storico Italiano e delle deputazioni locali di Storia Patria, ma che – d’altra parte – sul terreno della ricerca sull’eredità materiale del passato e della sua tutela “sul campo”, portò all’esito del riconoscimento, da parte dello Stato, dell’archeologia come disciplina che doveva occuparsi solo di ciò che concerneva l’età antica. Il Medioevo era escluso totalmente da questo tipo di processo conoscitivo e, al più, poteva essere oggetto di attenzioni da parte di architetti e storici dell’arte. Il binomio fra archeologia (cioè ricerca dell’antico) ed arte classica, formatosi nella temperie del Rinascimento e consolidatosi nella stagione del Neoclassicismo tardosettecentesco e del primo Ottocento finì così per saldarsi, nella legislazione italiana, al riconoscimento di un patrimonio archeologico funzionale principalmente alla promozione delle memorie di una romanità trionfante ed esemplare nella sua opera di civilizzazione dell’intero territorio italiano. Questo approccio predata considerevolmente l’avvento del Fascismo, anche se in quel periodo troverà un’applicazione più sistematica ed ideologicamente aggressiva, connessa ad interventi di rimodellamento urbano miranti a rendere esplicito il legame viscerale esistente fra le città del presente e l’eredità dell’antico (Barbanera 2015). L’esclusione del Medioevo dal quadro delle tutele esercitate dallo Stato in campo archeologico ha determinato conseguenze soprattutto per le testimonianze materiali del primo Medioevo, ed in particolare per quelle relative alle tracce riconducibili alle fasi iniziali della presenza dei popoli “barbarici” stanziatisi sul territorio italiano, dato che di esse era difficile trovare traccia architettonica o comunque monumentale. Tra la fine dell’800 e gli inizi del ‘900 in Italia sono stati numerosi i casi di rinvenimenti – quasi sempre fortuiti – di aree funerarie che hanno restituito reperti riconducibili al contesto delle culture germaniche. Ma la loro esplorazione solo in poche circostanze è stata sistematica e mai in grado di innescare un’attenzione stabile verso questo tipo di tracce archeologiche (La Rocca 1993). Le cose, in Italia, sarebbero effettivamente cambiate solo nel corso del secondo dopoguerra, per il progressivo mutamento d’intendimenti e d’indirizzi sia delle scienze storiche del Medioevo, sia della stessa archeologia classica. Essi furono resi possibili anche dal clima culturale prodottosi con il naufragio del progetto ideologico che aveva visto l’archeologia classica rappresentare un puntello rilevante per la costruzione dell’identità nazionale post-unitaria. Per quanto concerne le prime, l’approfondimento di tematiche suscitate in primo luogo dagli studi storico-giuridici, come quelle relative ai contratti agrari e alle condizioni del possesso della terra nei secoli di passaggio dall’Antichità al Medioevo, aprì progressivamente la consapevolezza che le fonti scritte non erano – da sole – in grado di rispondere a tutti gli interrogativi che esse stesse ponevano. Fra questi, preminenti furono quelli che, ispirati principalmente dalle lungimiranti visioni di Gian Piero Bognetti, vertevano sulle condizioni d’insediamento dei popoli migranti nel territorio italiano, sulle forme materiali che tale insediamento poteva aver assunto e sui rapporti che tale innesto poteva aver avuto con l’eredità organizzativa e materiale del territorio in età antica (Vismara 1966). In merito all’archeologia classica, sulla spinta delle scienze sociali e con il decisivo contributo dell’approccio d’impostazione marxista allo studio delle società del passato, maturarono progressivamente nuove idee sulla possibilità che le belle arti non dovessero necessariamente costituire l’unico obbiettivo dell’indagine sulle tracce materiali delle società del passato. Questi cambiamenti hanno finalmente sdoganato, nel corso degli anni ’60 del XX secolo, una visione dell’archeologia che superasse gli steccati tradizionali di ambito sia cronologico, sia epistemologico. Nello specifico, l’archeologia medievale riuscì finalmente a trovare un suo riconoscimento istituzionale, con l’istituzione delle prime cattedre universitarie dedicate (a partire dal 1968, con Michelangelo Cagiano de Azevedo) e la nascita di sedi scientifiche accreditate (la rivista “Archeologia Medievale”, pubblicata a partire dal 1974) attraverso cui divulgare presso la comunità degli studiosi i risultati dei lavori sul campo. E va ricordata anche l’istituzione, nel 1967, del Museo dell’Alto Medioevo a Roma, promossa in primo luogo dallo storico dell’arte Mario Salmi, nel quale s’intendeva – per la prima volta – dedicare uno spazio espositivo specificamente all’archeologia dell’età postclassica (Scarpa 2016). Sebbene nei suoi primi due decenni di vita accademica, l’archeologia medievale italiana abbia frequentato in modo prevalente i secoli del pieno e basso Medioevo, anche indirizzi d’indagine incentrati sulla fase iniziale di questo periodo storico hanno progressivamente preso piede, divenendo poi prevalenti nei tempi più recenti. Ciò è stato possibile anche grazie ad un progressivo e virtuoso avvicinamento fra l’archeologia medievale vera e propria e l’archeologia cristiana, una disciplina di assai più antica origine e l’unica ad aver operato nel corso di tutto il Novecento su temi che oltrepassassero cronologicamente i limiti dell’Età Antica, quantunque limitati al solo studio di monumenti e testimonianze materiali che fossero rilevanti per la storia del culto cristiano. In tale nuovo contesto, è finalmente fiorita in Italia una sistematica attività di ricerca e di tutela relativa alle tracce riferibili alla presenza dei Longobardi, che nello spazio di poco tempo ha letteralmente rivoluzionato le conoscenze relative a questo popolo e all’epoca in cui esso ha dominato la scena storica italiana. Gli esiti delle attività di ricerca sul campo hanno condotto rapidamente alla produzione di opere di sintesi sull’archeologia dell’età longobarda, fra le quali va ricordata innanzitutto quella di Alessandra Melucco Vaccaro, apparsa nel 1982. In questo importante volume, negli anni successivi a dire il vero un po’ ingiustamente dimenticato, il panorama della cultura materiale longobarda appariva molto limpido nella sua composizione e nei suoi processi evolutivi. Sulla scorta principalmente degli studi condotti da studiosi tedeschi sin dai decenni dell’anteguerra (con una prospettiva talora fortemente condizionata dalla finalità di dimostrare la preminenza della presenza germanica nel quadro europeo post-antico), i ritrovamenti tombali componevano un quadro all’interno del quale si potevano distinguere, attraverso le evoluzioni tipologiche dei manufatti, sia fasi diverse nel modo in cui i corredi funerari maschili e femminili erano composti e nell’aspetto che essi assumevano, sia differenziazioni relative ai medesimi due aspetti all’interno di una medesima fase cronologica. Il libro della Melucco Vaccaro era stato preceduto di qualche anno da un evento espositivo che proponeva per la prima volta al pubblico il racconto della cultura longobarda attraverso le tracce archeologiche e artistiche riferibili al periodo storico in cui questo popolo dominò la scena italiana. Parliamo della mostra “I Longobardi e la Lombardia”, tenutasi al Palazzo Reale di Milano nel 1978, nella quale appariva chiaro come, in quella fase ancora pionieristica dell’archeologia medievale italiana, le competenze fossero ben distinte fra scuole e tradizioni di diversa origine (Arslan – D’Assia – Calderini 1978). Gli studiosi italiani vi appaiono in grado di dominare il campo dell’analisi storica, linguistica e storico-artistica, ma i padroni del campo in quella dei manufatti archeologici provenienti dai contesti funerari sono tutti tedeschi, a certificazione del ritardo con cui l’accademia italiana aveva affrontato il problema delle tracce materiali del proprio Medioevo. Il ricordato volume della Melucco Vaccaro, grazie agli studi specificamente condotti proprio da questa studiosa, rappresentò già un primo segno in controtendenza rispetto alla situazione rappresentata dalla mostra milanese, ma si sarebbe dovuto attendere un altro decennio per vedere i segni di un’evoluzione ulteriore, caratterizzata soprattutto dall’emergere di nuove prospettive e approcci metodologici nell’analisi archeologica dell’età longobarda. Nel 1990, infatti, si tenne in Friuli la prima grande “mostra nazionale” sui Longobardi, curata da Gian Carlo Menis (Menis 1990). Già ad un primo sguardo si può notare che essa fu in grado di proporre un parterre di materiali esposti significativamente più ampio rispetto a quello su cui la Melucco Vaccaro, solo pochi anni prima, aveva potuto basare la sua sintesi. Ma le differenze – come si è detto poc’anzi – risaltano anche sul piano del metodo e delle tematiche affrontate. Se infatti l’analisi dei manufatti recuperati da scavo nel quadro principalmente di contesti funerari appare ancora appannaggio di studiosi come Volker Bierbrauer e Ottone d’Assia, esponenti della scuola tedesca di più antica tradizione, appare – proprio a firma di Ottone d’Assia – un saggio sul processo di acculturazione dei Longobardi all’interno del quale inizia a farsi strada una riflessione, condotta attraverso i dati archeologici, sull’interazione fra il retaggio culturale “tradizionale” dei Longobardi e il substrato culturale, economico e produttivo da essi trovato al momento dell’ingresso in Italia. Un tema che, sempre all’interno del catalogo della mostra, un altro inedito spunto di approfondimento, a cura di Gian Pietro Brogiolo, è quello dell’analisi dei dati materiali relativi alle condizioni dell’insediamento urbano e rurale al momento dell’arrivo dei Longobardi ed alla loro evoluzione nel corso dei due secoli successivi. L’attenzione posta su questo specifico aspetto, si può ben comprendere, sdoganava lo studio delle tracce archeologiche di questo periodo dal limbo di una loro alterità rispetto al retroterra dell’archeologia dell’Italia in Età Antica, inserendole nel quadro dell’analisi dell’organizzazione ereditata dal periodo romano e quindi, “di diritto”, in quello di un’archeologia che non concepiva più gerarchie e priorità preconcette, ma guardava alle tracce del passato come ad un continuum testuale di cui ogni periodo storico aveva scritto una pagina inestricabilmente connessa a quelle precedenti e a quelle susseguenti. La mostra del 1990 è stata, come si diceva in precedenza, anche la prima “mostra nazionale” sui Longobardi. Il ricco catalogo reca infatti schede di reperti esposti e di siti e monumenti distribuiti su tutto il territorio italiano, offrendo l’opportunità di una valutazione complessiva della diffusione del patrimonio riferibile al periodo della dominazione longobarda e – con un’ulteriore novità - evidenziando agli occhi del grande pubblico la rilevanza particolare di quello concentrato nelle regioni dell’Italia meridionale, per le quali tale periodo si estende ben oltre la data del 774 (anno della conquista del regno longobardo da parte dei Franchi), giungendo sino ad oltre la metà dell’XI secolo. Passarono altri dieci anni e, nel 2000, si tenne a Brescia una seconda mostra sui Longobardi, curata da Carlo Bertelli e Gian Pietro Brogiolo (Bertelli – Brogiolo 2000). Se quella friulana del 1990 può essere considerata la prima “mostra nazionale” sul tema, quella di Brescia può essere invece a buon diritto letta come il primo evento espositivo che lo proiettava su una prospettiva internazionale. Il titolo stesso (“Il futuro dei Longobardi. L’Italia e la costruzione dell’Europa di Carlo magno”), rifletteva la consapevolezza, ormai maturata attraverso il progresso della ricerca archeologica, che la fenomenologia della presenza longobarda in Italia fosse non solo parte integrante del più vasto movimento di popoli che si verificò al tornante fra Antichità e Medioevo, ma anche che l’esperienza dei due secoli di dominazione della Penisola costituì una componente non secondaria del quadro politico e culturale dell’Europa carolingia. L’originale elaborazione dell’eredità antica avvenuta in Italia durante quel periodo non sarebbe stata insomma da considerarsi un fenomeno periferico e locale, ma avrebbe contribuito ad aprire le regioni dell’Europa dominate dai Franchi al contesto mediterraneo, agevolando anche i contatti con i mondi bizantino e islamico. L’Italia longobarda, insomma, pur se alla fine soccombente sul piano politico, sarebbe stata per il mondo transalpino come una sorta di Graecia capta, in grado di rendere l’eredità di Roma pienamente operante all’interno dell’Europa post-classica e non quindi semplicemente una provincia marginale al traino di un baricentro politico gravitante fra Loira e Reno. Non può sfuggire la rilevanza di questa impostazione concettuale nel quadro di un’Europa che, alle soglie del terzo millennio, si preparava ad affrontare tappe decisive dell’ampliamento e del rafforzamento del suo progetto unitario, ma all’interno della quale – come si sarebbe poi visto negli anni successivi – non mancavano elementi di squilibrio e di latente malessere rispetto alla prevalenza della componente franco-tedesca. E non può sfuggire neppure come questa mostra si fosse posta temporalmente a ruota del grandioso evento espositivo tenutosi solo un anno prima a Paderborn, al centro di una Germania da poco riunita, a celebrazione dell’anniversario dell’incontro ivi avvenuto nel 799 fra Carlo Magno e papa Leone III (Stiegemann - Wemhoff 1999). Un fatto storico, questo, considerato il prodromo della definitiva consacrazione del re franco – attraverso la sua incoronazione imperiale romana dell’anno 800 – a dominus di un’Europa che sembrava essersi definitivamente riassestata su nuove basi dopo il crollo del sistema geopolitico dell’Impero Romano. Ma, anche a prescindere dai suoi più o meno espliciti intenti politico-culturali, la mostra di Brescia ha rappresentato uno spartiacque decisivo nella percezione diffusa della componente longobarda della storia nazionale italiana, poiché di essa furono nell’occasione proposte letture assai ampie e per diversi aspetti molto innovative, derivanti dall’avanzamento degli studi compiuto nel corso degli anni ’90. Giova ad esempio ricordare l’analisi della mutazione culturale avvenuta nel corso del VII secolo, che avrebbe portato all’estinzione di costumi – come quelli delle deposizioni funerarie con corredo – tipici della fase iniziale dell’insediamento longobardo in Italia e all’affermazione di nuove tradizioni derivanti dall’adesione al Cristianesimo, quale l’impegno delle aristocrazie nella fondazione di chiese e monasteri e, quindi, la diffusa promozione di attività artistiche fiorite nel solco della tradizione antica. A traino, si può dire, di questo tema, nella mostra trovò anche un primo e compiuto momento di valutazione quello dell’analisi della produzione scrittoria – epigrafica e libraria – che rivelò una ricchezza in grado di smentire molti luoghi comuni sull’estinzione della cultura letteraria dell’Italia altomedievale e portò molta acqua al mulino della sua rappresentazione come area centrale nel panorama intellettuale europea dell’epoca. Anche altri furono gli argomenti innovativi di questa mostra: fra questi, l’avvio di un processo di rilettura del panorama dei ritrovamenti funerari, all’interno del quale si affacciava una tendenza a smarcare da una connotazione spiccatamente “etnica” anche gli oggetti di ornamento personale tradizionalmente considerati più tipici di una cultura (e di un’estetica) di ascendenza germanica, per considerarli piuttosto – nell’insieme che essi andavano a comporre all’interno delle sepolture – come indicatori del rango sociale del defunto. Alle soglie del XXI secolo una nuova generazione di studiosi si era ormai sostituita a quella che ancora aveva dominato nell’esposizione friulana del 1990, aprendo fra l’altro nuovi orizzonti sui temi della storia dell’insediamento urbano e rurale e dei rapporti fra aree longobarde e bizantine d’Italia. Quella di Brescia fu insomma, per alcuni versi, una mostra irripetibile – anche grazie alla disponibilità di risorse per un evento di questo tipo impensabile nell’Italia di oggi – perché seppe unire buona parte delle scuole di pensiero e gli specialismi che avevano contribuito, nel nostro Paese, a rendere l’archeologia del Medioevo una disciplina in grado di costruire la storia e di dialogare alla pari con le scienze storiche e storico-artistiche da cui essa si era progressivamente distaccata. La “spendibilità” dei Longobardi come tema per eventi espositivi non si esaurì con la mostra di Brescia. Nel decennio seguente si ebbero infatti altre due opportunità di tornare sull’argomento. Nel 2007, a Torino, si tenne la mostra “I Longobardi, dalla caduta dell’Impero all’alba dell’Italia” (Brogiolo – Chavarría Arnau 2007), il cui focus tematico era costituito dall’estremo cronologico opposto a quello privilegiato a Brescia. Nell’occasione si rivolse infatti un’attenzione particolare al periodo antecedente l’arrivo dei Longobardi (partendo dal V secolo) con il fine di descrivere le condizioni che questi trovarono al momento del loro arrivo in Italia (nel 568) e quindi analizzando se e in che misura questo evento abbia inciso sul processo di dissolvimento degli equilibri sociali, politici ed economici del mondo antico. Ma non va trascurata una sezione specifica del catalogo, di un approfondimento sul tema della percezione del passato longobardo nella cultura storica e letteraria dell’Italia fra Basso Medioevo e Ottocento, questione cruciale, di cui si è discusso all’inizio, per capire come mai nel nostro Paese si sia avviato con tanto ritardo lo sviluppo di un’archeologia dedicata all’investigazione di questo specifico aspetto. Nel 2008, infine, si tenne a Rende, presso Cosenza, la mostra “I Longobardi nel Sud” (Coscarella 2008 – catalogo - e Roma 2010 – saggi) alla quale si deve un primo tentativo di leggere sinotticamente il peculiare contesto storico in cui si svolse la lunga parabola di una presenza che, contrariamente a quanto avvenne nelle Regioni del Centro e del Nord, occupò tutti i secoli dell’Alto Medioevo, spingendosi sin oltre la metà dell’XI secolo. In alcuni casi, come quello della Basilicata e della Calabria, la mostra ha esplorato e raccontato territori fin allora virtualmente sconosciuti (se non agli addetti alla ricerca) e inaspettatamente più ricchi di quanti fosse lecito immaginare, anche se è mancato nella circostanza un approfondimento dei rapporti fra Longobardi, Bizantini e Arabi che ha caratterizzato in modo peculiare il contesto meridionale dell’Alto Medioevo. Si giunge quindi all’oggi e alla mostra che, inaugurata a inizio settembre 2017 presso i Musei Civici del Castello Visconteo di Pavia, migrerà prima al Museo Archeologico Nazionale di Napoli a dicembre per poi approdare, nella primavera del 2018, all’Ermitage di San Pietroburgo (Brogiolo – Marazzi – Giostra 2017). È più difficile parlare di un qualcosa in cui si sia direttamente coinvolti, ma vi è allo stesso tempo il vantaggio di poterlo fare dichiarando in prima persona (e non interpretando il pensiero di altri) quali siano stati gli obbiettivi scelti per la costruzione di questo evento. L’idea di una nuova mostra è scaturita essenzialmente da tre input principali. Il primo è stato rappresentato dalla disponibilità dell’Amministrazione Comunale pavese a colmare l’evidente lacuna che aveva visto la città che fu a lungo capitale del regno longobardo e custode di monumenti e collezioni museali di primaria importanza per questo periodo storico essere rimasta a latere dei grandi eventi ad esso legati. Il secondo motivo scaturisce dalla rilevante messe di nuovi rinvenimenti archeologici di età longobarda verificatisi nel corso del primo decennio del XXI secolo, che avevano condotto anche ad allestimenti museali che hanno arricchito notevolmente il panorama italiano del “Medioevo longobardo esposto”, come ad esempio quelli realizzati al Museo Archeologico di Torino, al Civico Museo Archeologico di Milano e in quello di Ascoli Piceno. L’ultimo motivo era quello di tirare le fila di un dibattito, accesosi tra la fine degli anni ’90 ma giunto a maturazione nei primi del 2000, che dalle ragionevoli premesse di una volontà di attenuazione della tradizionale lettura della cultura materiale longobarda (soprattutto quella riferibile ai ritrovamenti di ambito funerario) come segno distintivo tout-court dell’appartenenza etnica del defunto, è giunta in tempi recenti ad esiti estremi di destrutturazione e negazione di qualsiasi possibilità di riconoscimento oggettivo di contesti culturali riferibili alla componente originale longobarda presente sul territorio italiano. Una posizione, questa, che ha trovato spazio soprattutto in ambienti accademici esteri, ma che non ha mancato di produrre seguaci anche in terra italiana. Le premesse di questa impostazione concettuale vanno ricercate tutte nella volontà di ammorbidire l’idea che l’incontro fra il mondo romano e le popolazioni che s’insediarono progressivamente nei suoi territori fra V e VI avesse partorito contrasti culturali forti, basati su nette differenze culturali a monte fra gli uni e gli altri. Insomma, il tutto verteva (e verte tuttora) sull’idea che gli eventi che portarono alla fine dell’Impero siano stati uno scontro fra identità “deboli”, non in grado di elaborare (certamente non da parte dei barbari) visioni preconcettualmente ostili gli uni degli altri. È stato ben chiarito come questa fase storica potesse essere presa a spunto per istituire paragoni con realtà contemporanee molto vive e percettibili già negli anni ’90 nel mondo anglosassone, ove il problema dell’integrazione culturale all’interno del cosiddetto melting pot della società post-coloniale britannica e di quella estremamente composita degli USA aveva (e ha ancora oggi) creato problemi non indifferenti. Ma non va neppure sottovalutata la preoccupazione, particolarmente viva nel mondo germanico, relativa all’uso che della “disseminazione germanica” sul continente europeo seguita alle invasioni – che l’archeologia barbarica tradizionale avrebbe puntellato di dati ed evidenze - si è fatto fra ‘800 e ‘900 per giustificare, sul piano storico, i progetti di egemonia politica che i Tedeschi hanno avuto sul continente europeo (vedi una panoramica delle diverse posizioni che caratterizzano questo approccio ad esempio i saggi raccolti in Noble 2006 e, per una lettura di segno diametralmente opposto Ward-Perkins 2008, Delogu 2015 e Berto 2016). La decostruzione di una koiné identitaria dei popoli germanici ha risposto quindi a sollecitazioni ben precise provenienti dal presente, che sino ad un certo punto hanno contribuito a rendere più ricco ed articolato l’approccio interpretativo ai resti archeologici provenienti dalle necropoli “barbariche”, spingendo a cogliere gli elementi di relazione che queste hanno intrattenuto con il contesto entro cui questi popoli sono andati ad inserirsi. Esse hanno anche aiutato a valutare meglio i mutamenti sociali che i popoli migratori hanno subito nel corso del tempo ed a considerarli come portatori di culture in divenire e non sigillate entro eredità ancestrali impermeabili agli influssi dei mondi con cui essi entrarono in contatto. Ma questa visione non può approdare alla negazione che i popoli che entrarono nell’Impero non fossero latori di proprie identità, riti e tradizioni, di cui l’archeologia rivela segni distintivi, e che tali segni fossero leggibili attraverso linguaggi formali di cui diverse categorie di oggetti di ornamento personale, rinvenuti nelle sepolture, possono essere considerati emblematici. Inoltre, è evidente che le medesime categorie di oggetti (ad esempio armi, fibule, fibbie, tipi specifici di cinture con i loro ornamenti ed altri tipi di oggetti di gioielleria) rivenuti nelle necropoli attribuite a Franchi, Alamanni, Goti e, infine Longobardi, presentano fra loro parentele formali indiscutibili, rivelando per questi popoli, pur ognuno con sue proprie peculiarità, l’esistenza di un retroterra comune, che certamente non va mitizzato né considerato come un moloch intangibile, ma che non può neppure essere negato in nome del presupposto di una assoluta flessibilità culturale delle popolazioni migranti e dell’assenza, presso di esse, di una coscienza di sé derivante da un qualche tipo di memoria storica condivisa. Negare recisamente l’evidenza che l’impatto delle popolazioni migranti sui territori dell’Impero romano abbia determinato anche scontri – talora assai aspri – fra identità culturali differenti fra loro non rende un buon servizio all’attendibilità della ricostruzione storica. Né tale attitudine aiuta meglio a capire il processo attraverso il quale i nuovi venuti abbiano costruito un quadro geopolitico e culturale diverso da quello che esisteva prima del loro arrivo, pur assorbendo – trasformandola e reinterpretandola – l’eredità della società tardoromana nel suo insieme. Anzi, sembra piuttosto che ciò tolga a popoli come i Longobardi la rilevanza storica che invece indubbiamente hanno avuto. Probabilmente, quella che la mostra di Pavia offre è una lettura che troverà accoglienze contrastanti, ma la mobilitazione di risorse ed energie anche significative per raccontare un pezzo della storia italiana non può limitarsi ad una mera esposizione di oggetti, senza che per essi si proponga un approccio critico nitido. Il dato interessante è però certamente quello dell’osservare che una pagina storica così lontana nel tempo possa colpire ancora sensibilità assai forti del nostro presente. Averle volute affrontare e interpretare attraverso una lettura dei dati archeologici in grado ormai di costruire visioni compiute dei processi storici ci è sembrata una sfida degna di essere raccolta. BIBLIOGRAFIA Arslan E., d’Assia O., Calderini C. (a c. di), 1978, I Longobardi e la Lombardia, San Donato Milanese. Artifoni E., 2000, Ideologia e memoria locale nella storiografia italiana sui Longobardi, in Il futuro dei Longobardi. L’Italia e la costruzione dell’Europa di Carlo Magno. Saggi, a c. di C. Bertelli – G.P. Brogiolo, Milano, pp. 219 – 227. Barbanera M., 2015, Storia dell’archeologia classica in Italia, Roma – Bari. Bertelli C., Brogiolo G.P. (a cura di), 2000, Il futuro dei Longobardi. L’Italia e la costruzione dell’Europa di Carlo Magno, 2 voll., Milano. Berto L.A., 2016, I raffinati metodi d’indagine e il mestiere dello storico. L’alto Medioevo italiano all’inizio del terzo Millennio, Mantova. Brogiolo G.P., Chavarría Arnau A. (a cura di), 2007, I Longobardi, dalla caduta dell’Impero all’alba dell’Italia, Milano. Brogiolo G.P., Marazzi F., Giostra C. (a cura di), 2017, Longobardi. Un popolo che cambia la storia, Milano. Coscarella A. (a cura di), 2008, I Longobardi del Sud. Catalogo della mostra, Viterbo. Delogu P., 2015., Ritorno ai Longobardi, in Desiderio. Il progetto politico dell’ultimo re longobardo, a c. di G. Archetti, Spoleto, pp. 19 – 50. Kidson P., 1996, Gotico, in Enciclopedia dell’Arte Medievale, Roma, http://www.treccani.it/enciclopedia/gotico_%28Enciclopedia-dell%27-Arte-Medievale%29/ La Rocca M.C., 1993, Uno specialismo mancato. Esordi e fallimento dell’archeologia medievale italiana alla fine dell’Ottocento, «Archeologia Medievale», 20, pp. 13 – 43. Marri F., 2013, Ludovico Antonio Muratori. Il contributo italiano alla storia del pensiero: storia e politica, Roma, http://www.treccani.it/enciclopedia/ludovico-antonio-muratori_%28Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Storia-e-Politica%29/ Marri F., s.a. (ma 2016), Biografia, Modena, in https://www.centrostudimuratoriani.it/muratori/biografia/ Melucco Vaccaro A., I Longobardi in Italia. Materiali e problemi, Milano. Menis G.C. (a cura di), 1990, I Longobardi, Milano. Noble T.F.X. (a cura di), 2006, From Roman Provinces to Medieval Kingdoms, London – New York. Roma G. (a cura di), 2010, I Longobardi del Sud, Roma. Scarpa A., 2016, Il Museo dell’Alto Medioevo a Roma, Tesi di Laurea in Storia delle Arti e Conservazione dei Beni Artistici, Università di Venezia “Cà Foscari”, a.a. 2015 – 2016. Stiegemann Ch., Wemhoff M. (a cura di), 1999, 799. Kunst und Kultur del Karolingerzeit. Karl der Große und Papst Leo III. in Paderborn, 3 voll., Mainz. Tafuro A., 2012, Niccolò Machiavelli, il principato nuovo e l’Italia, in L’unità nazionale nella filosofia italiana: dal Rinascimento al Risorgimento e oltre, a c. di T. Serra – E. Graziani, Roma, pp. 31 – 60. Vismara G., 1966, Gian Piero Bognetti, storico dei Longobardi, in G. P. Bognetti, L’età longobarda, I, pp. V – XIX. Ward-Perkins B., 2008, La caduta di Roma e la fine della civiltà, Roma – Bari.
Comments are closed.
|
Archivio
Gennaio 2023
Categorie
Tutti
Scarica qui i numeri completi della Rivista
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tutti i diritti sono riservati © Kinetès-Arte. Cultura. Ricerca. Impresa. 2016 |
|

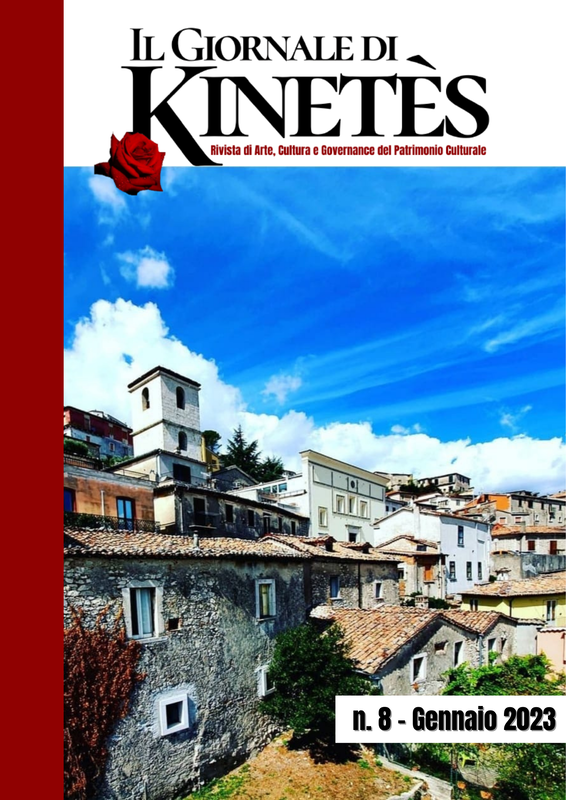

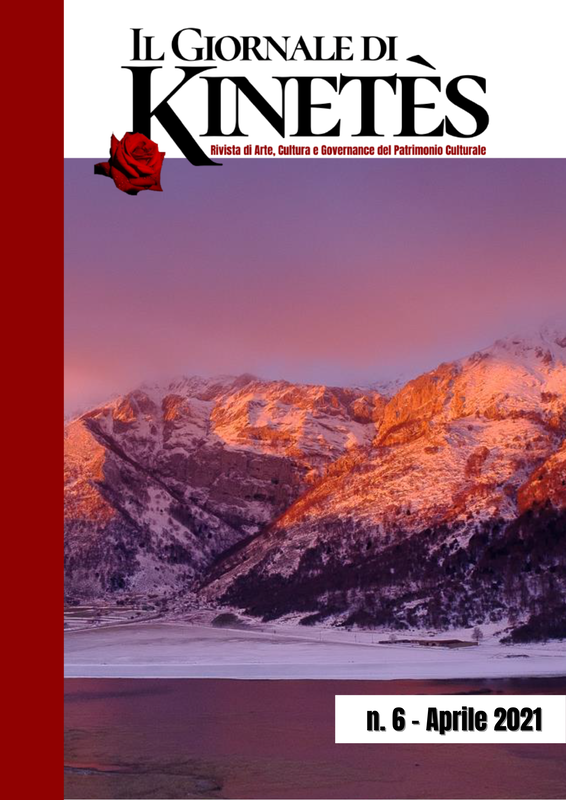
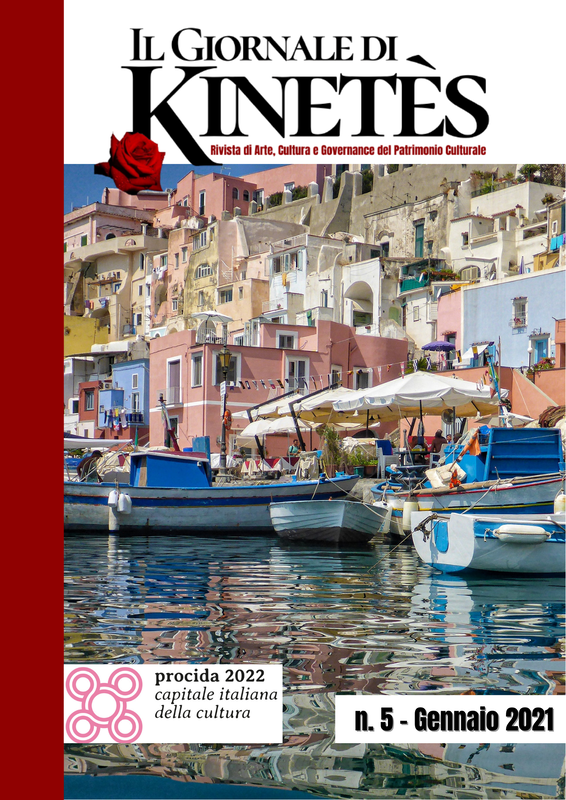
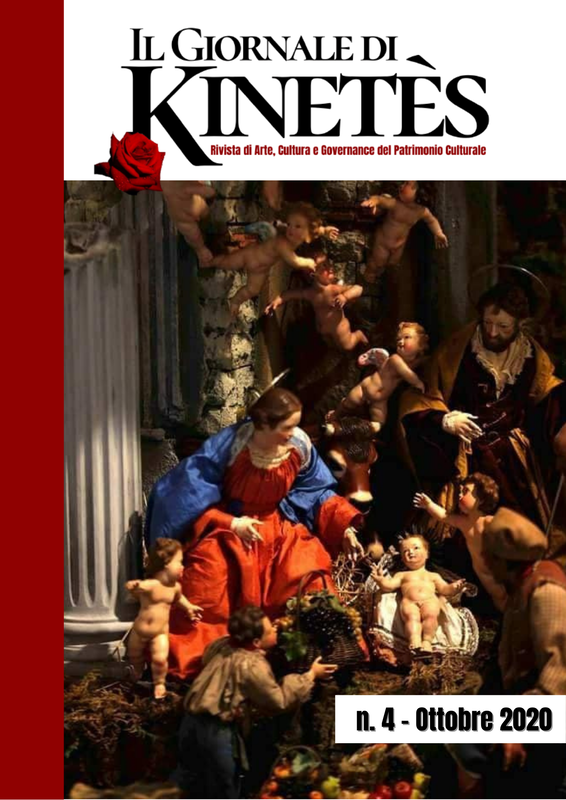



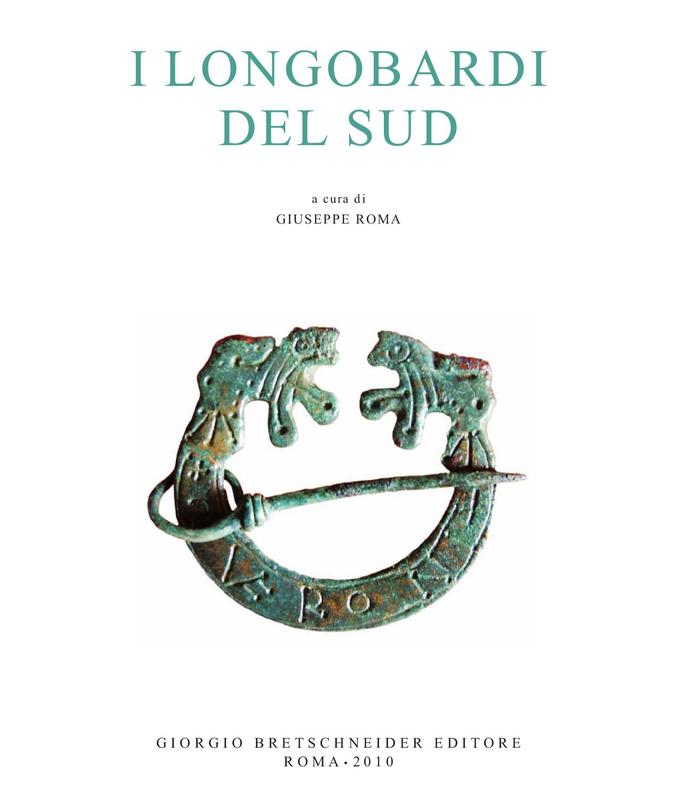


 Feed RSS
Feed RSS

